
La mente umana è guidata dal pregiudizio. In condizioni normali il nostro cervello bypassa il ragionamento razionale – troppo lento ed energeticamente inefficiente – a favore di una modalità cognitiva più agile e intuitiva, l’euristica. Il concetto di euristica cognitiva fu teorizzato a partire dagli anni ‘70 da Kahneman, Tverski[1] e successivamente Frederick,[2], e ci spiega come, per risparmiare tempo ed energie e farsi un’idea di un determinato argomento, di una persona o di una situazione, il nostro cervello usi scorciatoie cognitive. Le euristiche non si basano su dati, fatti e ragionamenti complessi ma su generalizzazioni e stereotipi, che quando però non corrispondono alla realtà portano all’errore, all’intuizione sbagliata: il bias.
Un tipo di euristica particolarmente interessante è il bias di conferma, la tendenza a selezionare e ricercare esclusivamente le informazioni che confermano idee e convinzioni che già avevamo in partenza. Questa tendenza spesso sfocia in quella che viene definita come echo chamber (o camera dell’eco), ossia l’amplificazione di determinate informazioni e idee dovute alla loro ripetizione costante. Quando siamo immersi in un ambiente come quello aziendale, in cui predomina il linguaggio del miglioramento personale ed è diffusa l’ideologia del superamento dei propri limiti, il nostro funzionamento euristico ci impedisce di notare che un determinato pensiero, per quanto apparentemente motivazionale, ispiratore e positivo, nasconda un tarlo: è fortemente abilista, ossia discriminatorio verso i differenti funzionamenti fisici, sensoriali e neurologici. Ne è un chiaro esempio la parola antifragile.
L’antifragilità è un concetto creato da Nassim Taleb[3], e descriverebbe il reale opposto di fragilità, che non è quindi resistente o resiliente. Un oggetto o una persona fragile devono evitare il caos e le situazioni stressanti per non rischiare di rompersi, chi (o cosa) è antifragile invece cresce e migliora proprio grazie al caos, allo stress. Secondo Taleb
“l’antifragilità va al di là della resilienza e della robustezza. Ciò che è resiliente resiste agli shock e rimane identico a sé stesso; l’antifragile migliora.“
Mi interessa particolarmente il concetto di antifragilità perché dimostra come le generalizzazioni siano tendenzialmente discriminatorie. Un’idea considerata positiva, utile e ispiratrice da una parte della popolazione, può rappresentare l’esatto opposto per coloro le cui caratteristiche non corrispondano a quelle della maggioranza delle persone.
Questo concetto rischia di contribuire a una realtà sempre più abilista che vede proprio le fragilità umane come difetti, e che spinge verso un ideale di miglioramento e superamento di alcune caratteristiche personali (che in questa narrazione diventano limiti) basandosi esclusivamente sulle proprie risorse. E tutto questo oltre a essere abilista è discriminatorio verso le differenze in generale.
L’antifragilità è nemica della tranquillità, della comodità e della routine, ed è molto amica delle sfide perché, secondo questa idea, le sfide ci permettono di diventare migliori. Bisogna mettersi alla prova e stare scomodi, insomma, perché dalla comodità non nascono idee, non si migliora. Anzi, l’autore si spinge fino a dichiarare che “Il modo migliore per verificare se siete vivi, è controllare se amate i cambiamenti”, dando praticamente del morto a tutte quelle persone che non solo non amano i cambiamenti (cosa legittima) ma che hanno difficoltà a gestirli perché ad esempio neurodivergenti (come noi autistici).
Vedete, il problema delle narrazioni che spingono al miglioramento, alla ricerca di forze ed energie interiori e al superamento dei cosiddetti limiti, è che non considerano la diversità come la condizione di base dell’umanità. Affermare che devi spingerti oltre, uscire dalla tua comfort zone e soffrire per migliorarti, presuppone prima di tutto che, così come sei, tu non vada bene.
 Inoltre, sostenere che devi aiutarti da solo, che devi superare i momenti critici con le tue forze perché solo così imparerai e sarai migliore, solleva la società da ogni responsabilità nei confronti dell’individuo e dei suoi diritti. Discorsi come questo sono alla base di quella modalità narrativa tanto utilizzata in certi ambienti e definita inspiration porn (di cui ho scritto qui, qui e qui), ossia l’uso della disabilità e della diversità come fonte di ispirazione per motivare la “normalità”. Ad esempio, la foto di un bambino che corre su gambe prostetiche con la didascalia: “La tua scusa è invalida”, veicola messaggi che oggettivano il corpo diverso (o la mente, i sensi, la cultura, l’età diversi) presupponendo che essi siano ostacoli da superare.
Inoltre, sostenere che devi aiutarti da solo, che devi superare i momenti critici con le tue forze perché solo così imparerai e sarai migliore, solleva la società da ogni responsabilità nei confronti dell’individuo e dei suoi diritti. Discorsi come questo sono alla base di quella modalità narrativa tanto utilizzata in certi ambienti e definita inspiration porn (di cui ho scritto qui, qui e qui), ossia l’uso della disabilità e della diversità come fonte di ispirazione per motivare la “normalità”. Ad esempio, la foto di un bambino che corre su gambe prostetiche con la didascalia: “La tua scusa è invalida”, veicola messaggi che oggettivano il corpo diverso (o la mente, i sensi, la cultura, l’età diversi) presupponendo che essi siano ostacoli da superare.
Ma è sufficiente parlare con qualche persona disabile o addentrarsi nei Disability Studies per comprendere che in realtà la disabilità non è un attributo della persona ma una responsabilità sociale. Un corpo diverso, ma anche un differente modo di percepire ed elaborare il mondo attraverso i sensi o una diversa organizzazione neurologica, non sono disabilità di per sé. Possono creare difficoltà, problemi, quello è innegabile. Ma una persona diventa dis-abile solo quando viene messa a confronto con una società che non ammette alcuna modalità di funzionamento differente da quella “normale”, da quella denominata “abile”; una società che disabilità i funzionamenti diversi dalla media.
È quindi l’interazione tra una persona con determinate caratteristiche e una società che contro di esse alza barriere o che semplicemente le ignora, a creare la disabilità. E questo discorso vale per l’esclusione di qualsiasi differenza: di orientamento sessuale, di genere, di cultura o provenienza, di credo religioso.
Attribuire alla singola persona la responsabilità dei propri successi anche solo sostenendo che ha nelle proprie mani il potere di migliorare, significa renderla responsabile delle proprie difficoltà anche quando non dipendono da lei. Semplificare a tal punto una realtà complessa significa sostenere che quel 78% di autistiche e autistici che non trova lavoro o non riesce a mantenerne uno[4], non va bene così com’è, deve diventare migliore, superare il proprio autismo. Significa che se sei nata in una famiglia con pochi mezzi economici e hai dovuto abbandonare gli studi da ragazzina, se ti sei sposata giovane e hai avuto dei figli, se lavori 10 ore al giorno per quattro soldi ma tu avresti voluto fare tutt’altro, diventare avvocata ad esempio, se non lo fai è colpa tua. Nonostante sia dimostrato che condizioni socioeconomiche sfavorevoli abbiano effetti negativi sul livello di studi che ci si può permettere di raggiungere e sulla salute fisica e mentale[5], creando un loop negativo del quale nella maggioranza dei casi la persona è l’ultima responsabile.
Il disagio, quello vero, il dolore dell’emarginazione causata dalla propria diversità o dalla mancanza di opportunità, spesso non sono strumenti per migliorare. Al contrario, la sensazione di disperazione che può provare una persona abbandonata a se stessa, senza il sostegno di quella società la cui ragione di esistere è proprio di creare supporto reciproco, può solo essere amplificata da ideologie e narrazioni come quella dell’antifragilità.
Forse invece di generalizzare, potremmo ragionare sulla necessità di apprendere a convivere con le persone che appaiono diverse da noi. Potremmo responsabilizzarci tutti di quelle barriere che impediscono alla diversità l’accesso a opportunità che oggi sono invece privilegi di una sola parte della società. Smettiamo di giudicare, di attribuire un valore al modo in cui le persone portano avanti la loro esistenza. Dalle difficoltà, dal dolore e dalla mancanza di opportunità non sempre si esce migliori da soli, ma quelle difficoltà possono essere superate dalla collaborazione di tutti, dalla condivisione di responsabilità, dal tentativo concreto di creare un mondo che non escluda la diversità, che garantisca a ciascunǝ l’opportunità di riuscirci, di vivere meglio. E meglio non significa diventare migliori, ma poter stare bene per come si è.
NOTE
[1] Tversky, A.; Kahneman, D. (1974). “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”. Science. 185 (4157): 1124–1131. Bibcode:1974Sci…185.1124T. doi:10.1126/science.185.4157.1124
[2] Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment (p. 49–81). Cambridge University Press. doi/10.1017/CBO9780511808098.004
[3] Taleb, N. N. (2014). Antifragile: Things That Gain from Disorder (Incerto) (Reprint ed.). Random House Trade Paperbacks.
[4] https://www.autism.org.uk/what-we-do/news/new-data-on-the-autism-employment-gap
[5] Sweeney, M. (2015, September). Stop Skipping Class: Why socioeconomic status (SES) matters. The SES Indicator Newsletter.




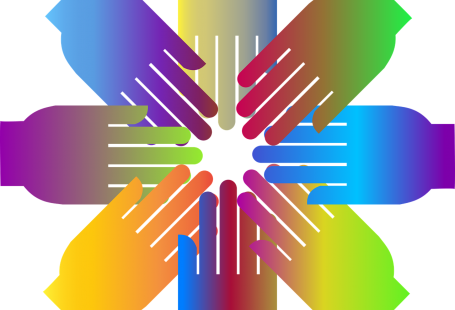
3 comments On Antifragilità: per molti, ma non per tutti.
Credo che dovremmo smettere di giudicare e giudicarci che non significa solo “dobbiamo accettarci” significa convivere con le nostre forme e capacità
Paola
Giusto, grtazie per l’osservazione!
Pingback: La “tirannia della presenza permanente” – Fabrizio Acanfora ()