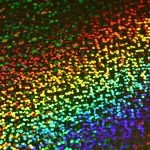Se foste concessionarie di una casa automobilistica, vendereste mai un modello di automobile dalla linea elegante, dotata delle più moderne tecnologie che però ha un problema: se si superano i 40km/h o se ci si cammina per più di 10 minuti, il motore si fonde? Probabilmente nessuna di voi che fosse a conoscenza di un tale difetto di fabbricazione proverebbe a rifilare una macchina che, nonostante sia bellissima e tecnologicamente avanzata, è buona solo da tenere in garage. Eppure tutte quante continuiamo a spacciare l’inclusione come “la soluzione” alla difficile convivenza delle differenze in questa società sempre più diversa, nonostante sappiamo ormai con certezza che questo processo nella pratica non funziona perché contiene in sé un difetto di fabbricazione ormai evidente: l’inclusione è discriminatoria.
Il processo che noi chiamiamo inclusione dev’essere messo in moto coscientemente. Diciamo che, per com’è concepito, è più un processo cognitivo che una realtà culturale. Spesso sentiamo parlare di “cultura dell’inclusione” e la immaginiamo come se fosse inscritta nel nostro patrimonio genetico culturale ma temo che, per com’è messa in pratica oggi, questo passaggio non avverrà.
L’applicazione e la successiva istituzionalizzazione del concetto di normalità all’essere umano è cominciata nella prima metà del 1800 ad opera di Adolphe Quetelet, proseguita poi da Francis Galton e dai suoi seguaci eugenetici (e qui uso il maschile perché erano tutti uomini), e la creazione del cosiddetto uomo medio è quindi un fatto recente nella nostra evoluzione culturale. L’idea di normalità è divenuta parte integrante della nostra cultura e delle idee che ci guidano nella costruzione della realtà poco più di un secolo fa, ma ciascuno di noi vive come se esistesse davvero da sempre una realtà normale.
Ovviamente l’esclusione, il bullismo e l’emarginazione non sono cominciati con la nascita della statistica applicata alla società – cioè con la nascita del concetto di normalità – ma da essa hanno ottenuto una giustificazione razionale e la possibilità di venire applicati su larga scala e in modo sistematico anche grazie all’emanazione di leggi e regole.
In molti casi l’istituzionalizzazione della discriminazione è risultata semplicemente dall’applicazione dei parametri della normalità alla vita di tutti i giorni: nel momento in cui la politica, la scuola, il lavoro oppure la medicina abbracciano ufficialmente l’idea di una normalità che si manifesta attraverso l’espressione di determinate caratteristiche fisiche, psicologiche, neurologiche o culturali, tutto ciò che non appartiene a tale categoria è per forza di cose considerato a-normale. Certo, se a tale a-normalità non corrispondesse un giudizio sempre negativo forse non ci sarebbe niente di male nell’appartenere a una minoranza. Il problema è invece che, a chi ricade al di fuori del gruppo della normalità, o mancano determinate caratteristiche ritenute positive e indispensabili, o presenta caratteristiche ritenute negative e non gradite, o entrambe le cose. E così, da circa 150 anni, vale per tutte l’idea che normale = giusta, e anormale = sbagliata (per una breve storia del concetto di normalità, potete leggere questo articolo).
Anormale è oggi quindi sinonimo di diverso. E in una società estremamente complessa e in continuo mutamento, una realtà definita liquida per la fluidità, la volatilità con cui le strutture che la regolano si trasformano cancellando il presente e proiettandoci costantemente verso un futuro sempre più incerto, in tale società la diversità ha cominciato a rappresentare un problema serio. Principalmente perché le minoranze hanno iniziato a disturbare, a farsi sentire pretendendo diritti che fino a poco fa erano prerogativa della cosiddetta classe dominante composta essenzialmente da uomini eterosessuali, bianchi, neurotipici e non disabili.
Cominciando dalle lotte per i diritti delle donne, degli afroamericani negli Stati Uniti, poi degli omosessuali e arrivando oggi alle richieste della comunità neuroatipica, la diversità è diventata un problema evidente e impossibile da nascondere sotto il tappeto perché chiede il riconoscimento dei propri diritti alle istituzioni.
Per comprendere e gestire il fenomeno di queste minoranze che hanno cominciato, guarda un po’, a pretendere gli stessi diritti e le stesse opportunità della maggioranza, sono nati concetti come quello di integrazione e di inclusione applicati ai gruppi sociali e culturali. Ma se l’integrazione è ormai da molti vista come discriminatoria perché presuppone l’abbandono della propria identità da parte del diverso e l’accettazione dei valori e delle modalità di funzionamento della maggioranza per poter esservi accolto, l’inclusione – che teoricamente dovrebbe essere un passo avanti rispetto all’integrazione – è destinata a fallire per gli stessi motivi che hanno determinato il fallimento dell’integrazione: è un processo esclusivamente verticale che mantiene lo squilibrio di potere tra maggioranza e minoranze.
Nello specifico l’inclusione, per come viene applicata oggi, è un processo che possiamo definire top-down, ossia che parte dall’alto e viene lasciato cadere verso il basso, un’azione che deve essere attivata dalla maggioranza la quale coscientemente permette a una minoranza di entrare a far parte della propria cultura, di essere parte della società. Ma, nonostante tutti ci affanniamo a sottolineare quanto l’inclusione sia diversa dall’integrazione perché non richiede alla persona che viene inclusa di abbandonare la propria identità, nella pratica sappiamo bene che non è così, e che questi due fenomeni si assomiglino enormemente.
Principalmente, a rendere l’inclusione un fenomeno discriminatorio c’è lo squilibrio di potere a cui accennavo prima per cui chi appartiene alla maggioranza può permettersi il lusso di decidere di volta in volta se e chi includere, a chi permettere l’accesso al proprio gruppo, mentre dall’altra parte la persona che viene inclusa subirà tale concessione che può esserle però revocata da un momento all’altro. Se questa è parità, allora va tutto bene.
All’inizio ho spiegato che l’inclusione non è un fenomeno culturale ma è un atto, un processo volontario. Per diventare parte della nostra cultura bisognerebbe che partisse contemporaneamente anche dal basso, invece di essere imposta dall’alto.
L’imposizione di valori funziona fino a che dura il potere che la mantiene. Altrimenti, al primo cambiamento politico o culturale, crolla. Sarebbe interessante invece se, piuttosto che imporre la rappresentatività della diversità con sistemi come le quote (che regolano l’accesso delle donne a determinate cariche, o di diverse etnie nelle università o nelle imprese), essa potesse diventare una naturale conseguenza della convivenza pacifica e costruttiva delle differenze in ogni ambito della nostra società.
Già, perché quella dell’inclusione è una falsa soluzione a un falso problema. La diversità è infatti già parte integrante della società, e non da ieri ma da sempre. Le donne, le differenti etnie, le differenze nell’orientamento sessuale o nel funzionamento neurologico, le varie culture e religioni hanno da sempre condiviso spazi comuni, e purtroppo non sempre in pace. Ma il problema più grande è che a queste minoranze non sono garantite pari opportunità di accedere al potere, di avere capacità decisionale, di auto-rappresentarsi e auto-determinarsi. E questo problema non si risolverà mai se a imporre qualche contentino per le minoranze sarà la maggioranza normale che teme più di ogni altra cosa la perdita del proprio potere e dei privilegi strappati al resto della popolazione con la creazione di una categoria, la normalità, che nella realtà rappresenta solo un’élite.
L’inclusione non funziona e lo dimostra il fatto che, nonostante se ne parli tanto e processi inclusivi vengano sbandierati da istituzioni pubbliche e aziende, la rappresentatività della diversità rimane ridicola, gli episodi di bullismo e discriminazione, di razzismo e abilismo sono all’ordine del giorno e quel gruppo, quell’élite chiamata maggioranza, si rintana con sempre maggiore forza e intransigenza verso posizioni di chiusura alla “concessione” di una parità che, in teoria, non dovrebbe nemmeno essere messa in discussione.
Fino a che si continuerà ad affidare alla cultura dominante della maggioranza la gestione della convivenza di tutte le differenti manifestazioni della diversità umana, tale convivenza sarà sempre gestita in modo da non far raggiungere mai ai gruppi sociali e culturali di minoranza una reale parità di diritti e opportunità, e questo avverrà principalmente evitando la formazione e la diffusione di una vera cultura della convivenza.
Anche la moda dell’inclusione della diversità nelle aziende segue le stesse dinamiche di potere, guardando alla diversità in termini di vantaggio e profitto economico. Le compagnie utilizzano infatti strumenti impositivi per applicare verticalmente i principi dell’inclusione al loro personale, nella speranza di vedere riprodotti quei vantaggi economici che sempre più studi ormai sbandierano come risultato di un ambiente lavorativo “diverso” e “inclusivo”: competitività, idee innovative, migliore performance, maggiore personalizzazione dell’offerta. Tranne che poi, anche in questo ambito e per gli stessi motivi, i risultati pratici non soddisfano nemmeno lontanamente le aspettative.
Il problema dell’inclusione è quindi prima di tutto culturale: un modello sociale in cui le differenze vengano comprese, osservate e non giudicate, utilizzate per migliorarsi tutti come comunità, non può essere imposto dall’alto. Per svilupparsi in modo organico una cultura ha bisogno di partire contemporaneamente anche dal basso. L’approccio dev’essere top-down per fornire garanzie istituzionali, programmi atti a favorire il mantenimento e l’osservanza delle regole della convivenza, ma contemporaneamente anche bottom-up, provenire cioè dalla gente, da una base coinvolta attivamente.
Ciascuno di noi deve trasformarsi coscientemente in co-creatore della cultura nella quale vive, essere coinvolto nello sviluppo attivo di una società che educa alla convivenza, all’apprendimento dalle differenze, alla difesa dell’unicità di tutte e tutti. Solo se sapremo rendere l’approccio alla convivenza un processo orizzontale in cui il potere e le responsabilità sono equamente distribuiti tra tutte le parti della società, potremo creare un’inclusione che superi le dinamiche discriminatorie che legano il potere alla concessione di quei diritti che oggi ancora sono i privilegi di una sola parte della comunità.