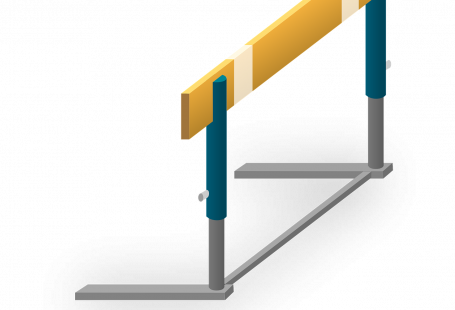Quando da bambino mi meravigliavo perché a qualcuno piaceva la montagna e non il mare oppure perché non mangiava lo yogurt, di cui io invece sono sempre andato matto, domandavo a mia madre come fosse possibile. E lei rispondeva sempre allo stesso modo: «Come posso saperlo io? Chiedi direttamente a lei, è lei che lo sa».
Da ormai tre anni tengo un seminario sulle condizioni dello spettro autistico all’Università di Barcellona. Tra le mie studentesse[1] ci sono pediatre, dottoresse, psicologhe, insegnanti di scuola primaria e secondaria, insomma, tutte persone che attraverso il proprio lavoro contribuiscono a creare la narrazione dell’autismo. E ogni anno mi accorgo di quanto poco ne sappiano, di quanto arrivino a lezione con un bagaglio di nozioni prodotte in serie, apprese da persone non autistiche o da libri che descrivono l’autismo come “patologia”, che parlano esclusivamente di deficit, di comportamenti da eliminare, da “migliorare”.
Quando chiedo loro di definire l’autismo, la risposta è generalmente sempre la stessa, da manuale: è un disturbo (quando va bene, altrimenti può essere una malattia) caratterizzato da deficit nell’area X, Y e Z. Amen, fine della storia.
Inizio la lezione ripercorrendo le tappe fondamentali dello sviluppo della diagnosi di autismo, di come gli studiosi siano partiti dall’osservazione di una condizione con alcune caratteristiche molto evidenti per arrivare al concetto odierno di spettro, a questa visione che piano piano sembra allontanarsi dalla diagnosi basata su categorie chiuse per avvicinarsi timidamente a un modello dimensionale che descrive gli individui non a causa della presenza o dell’assenza di una caratteristica, ma in base alla sua intensità.
E già sul concetto di spettro ci sono le prime difficoltà, perché risulta difficile comprendere quanto sfumato (e troppo spesso arbitrario) possa essere il passaggio tra un comportamento definibile come “normale” e uno “atipico”. Già, perché l’autismo (insieme a molte altre condizioni) viene diagnosticato in base all’osservazione del comportamento, il cui giudizio è influenzato dalla cultura, dal periodo, dal luogo, e a questa ovvietà ho notato che non sempre si presta sufficiente attenzione.
Ma ciò che mi colpisce ogni volta è la reazione dei miei studenti quando comincio a spiegare i vari “sintomi” elencati nei manuali diagnostici raccontandoli in prima persona e sostituendo quella parola usata con tanta disinvoltura che sa di condanna, “deficit”, con una definizione più neutra: “differenza”. Quando spiego che noi autistici e autistiche non abbiamo un “deficit” nell’area sociale ma che desideriamo stare insieme agli altri, solo che è difficile perché abbiamo modalità differenti di interagire, rimangono sempre colpiti. Perché per loro, che hanno studiato senza mai domandare a un’autistica cosa rappresentino per lei quei “sintomi” stampati sulle pagine di un manuale, noi neuroatipici non vogliamo e non sappiamo socializzare, ci manca qualcosa, siamo difettosi.
Quando spiego loro che a me piace stare in compagnia, ma di poche persone, in determinati momenti e in posti tranquilli perché ho difficoltà a seguire più di un discorso alla volta, perché i rumori si infilano nel cervello e mi impediscono di capire quello che mi si dice, perché se siamo in un ristorante con molta gente probabilmente verrò risucchiato da quel vortice di voci, posate che tintinnano, dalla ragazza al tavolo accanto che racconta all’amica del suo primo giorno al lavoro o dalle luci, dalle persone che si muovono intorno a me e agganciano la mia vista e allora cosa dicevi? Mi sono perso pezzi di conversazione, comincio a sentirmi ansioso; forse è il caso di uscire, non è che non voglia stare con voi, è che a queste condizioni per me è una fatica enorme.
Racconto che se il mondo intorno decide di venirmi incontro e ci si riunisce in pochi, si cerca di rispettare dei turni quando si parla, le luci sono naturali e non c’è musica a palla in sottofondo o gente che chiacchiera a voce alta, quando posso dedicare alle altre la mia attenzione perché i miei sensi non sono presi in quel vortice senza controllo, allora non c’è problema. Certo, rimane la questione dei diversi codici di comunicazione per cui io generalmente intendo le cose in modo più letterale, posso perdermi una battuta (non sempre) o non afferrare una metafora, ma dall’altra parte accade lo stesso: le mie battute spesso vengono fraintese, il mio linguaggio non verbale interpretato usando codici diversi dai miei può risultare incomprensibile.
Giorni fa ho scritto di quanto l’inclusione sia un processo verticale che arriva dall’alto come una concessione, sottolineando una differenza di potere tra chi “permette” l’ingresso in un gruppo e chi “riceve” questo permesso. Ho spiegato perché un’inclusione di questo tipo non può funzionare e ho suggerito un modello orizzontale, ma forse avrei dovuto dire “multidirezionale” che si muova anche dal basso verso l’alto e dai lati verso il centro, un’inclusione che non venga vissuta attivamente solo da chi la concede ma che implichi la partecipazione di tutte le parti alla creazione di una cultura in cui le differenze convivono insieme, con pari dignità.
Quello delle mie studentesse è un esempio lampante di questa verticalità. Delle professioniste che lavorano anche con autistici, che dovrebbero rappresentare un faro nel buio per tante famiglie che si affacciano al mondo dell’autismo e per tutte quelle persone che vi hanno a che fare anche indirettamente (e questo discorso vale per qualsiasi manifestazione della cosiddetta “diversità”) che non hanno mai visto l’autismo raccontato da un’autistica. Queste professioniste forniscono terapie, decidono strategie e interventi, consigliano le famiglie, le autorità scolastiche. Poi a volte fanno carriera e decidono linee guida, influenzano il modo in cui noi autistici veniamo percepiti dalla società modificando direttamente l’ambiente nel quale viviamo tramite quel processo chiamato inclusione Spesso le autistiche sono esclusivamente casi da risolvere, si approcciano a esse solo attraverso la lente del funzionamento neurotipico. Ci vedono come creature difettose a cui mancano pezzi più o meno grandi di normalità, di socialità, di comunicazione o di comprensione del mondo.
E lo stesso avviene nelle aziende, in cui ormai sta diventando quasi una moda fare training sulla neurodiversità e l’inclusione, corsi creati, strutturati ed erogati prevalentemente da persone che con la neuroatipicità hanno a che fare solo perché la studiano dall’esterno, fenomeno affascinante, creature da aiutare, a cui concedere il dono caritatevole dell’inclusione. Esperte di autismo neurotipiche che consigliano ai responsabili delle risorse umane come interagire con gli autistici, come strutturare i colloqui e il luogo di lavoro e non si capisce ancora bene perché, quando è pieno di autistiche che potrebbero spiegare l’autismo per conoscenza diretta. Come diceva mia madre: chiedi direttamente a loro, sono loro che lo sanno.
In modo simile accade alle conferenze sull’autismo, nelle quali normalmente la maggioranza dei partecipanti è neurotipica, e agli autistici viene concesso lo “spazio per un siparietto autobiografico, poi il resto del tempo è diviso tra i professionisti, quelli che hanno le cose importanti da dire”[2].
Questa è l’inclusione che arriva dall’alto, che noi “diversi” dobbiamo subire, bere o affogare, e ti conviene pure accontentarti. Quando a raccontare la diversità è solo la normalità il discorso sarà sempre falsato, penderà sempre e solo da un lato, e allora anche le decisioni che la società e la politica prenderanno nei confronti di chi è raccontata e percepita come diversa, saranno falsate perché rispecchieranno l’idea che una sola parte si è fatta dell’altra, senza però domandare alle dirette interessate se quella descrizione sia realistica, se quelle soluzioni adottate siano utili o gradite.
Quando parlo di inclusione orizzontale mi riferisco proprio alla necessità di ascoltare TUTTE le voci, non solo quelle di una parte. Non suggerisco che si ascoltino esclusivamente le autistiche, o i dislessici, i mancini, le persone LGBT, le disabili, ma vorrei che a chi oggi si trova ancora fuori da questa maggioranza artificiale venisse riconosciuto lo stesso valore di tutte le altre persone.
L’inclusione è un processo che deve partire anche dal basso, da chi con l’esperienza in prima persona racconta la propria realtà perché da quei racconti, dalla narrazione di ciascuna, nasce la narrazione di tutti e se io, appartenente a una categoria considerata minoritaria, esisto nell’immaginario collettivo solo grazie a una descrizione che non corrisponde a chi realmente sono, sarò sempre, perennemente in una condizione di svantaggio.
Nessuna voce vale più delle altre. Sarebbe ora che le voci della “diversità” venissero rispettate e considerate alla pari di quelle della “normalità”. Alla pari, perché non siamo né “speciali” né inferiori, non siamo ccreature da compatire o da riparare, e nemmeno da accettare o usare come ispirazione. Siamo, e basta, proprio come tutte le altre.
NOTE
[1] Il corso è seguito sia da studenti che da studentesse, ma in questo articolo non verrà utilizzato il maschile sovraesteso, che sarà casualmente alternato al femminile.
[2] Valtellina, E. (Cur.). (2020). L’autismo Oltre lo Sguardo Medico (Vol. 1). Erickson.