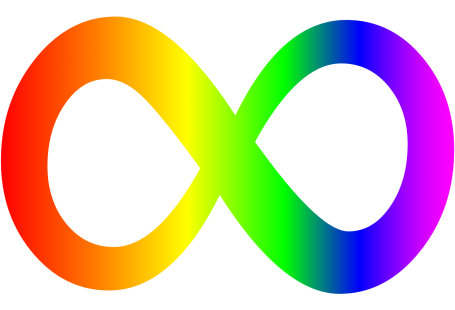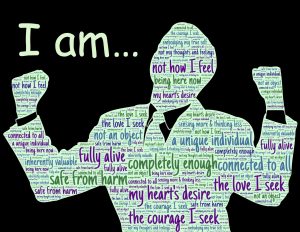
Durante un’intervista, ieri la giornalista mi ha domandato se, visto che parliamo di diversità e che ciascuna persona è diversa dall’altra, non sarebbe meglio abolire concetti come disabilità o autismo, perché creano una identificazione negativa nella persona che ne viene marchiata.
Certo, a prima vista si potrebbe pensare che sono etichette e basta, e che ovviamente vadano superate. E questo può essere vero se parliamo di un certo tipo di significato che viene loro attribuito, quello del funzionamento deficitario, della persona inferiore, incapace, non utilizzabile. Ma quelle stesse etichette sono fondamentali perché permettono la creazione di un’identità di gruppo, un’appartenenza culturale che è fondamentale per ciascun individuo, e che le persone appartenenti al gruppo culturalmente dominante, la maggioranza, possono serenamente dare per scontata.
Parlare quindi di autismo, di persone autistiche, continuare a usare questa etichetta ha un senso dal punto di vista politico e sociale, perché permette la creazione di una minoranza, cosa non necessariamente deleteria, ma anzi fondamentale per il raggiungimento di una visibilità sociale, politica e alla fine anche individuale in quanto persona con determinate caratteristiche.
Il problema è che per decenni, esattamente com’è accaduto per le persone disabili (o con disabilità, come molte preferiscono essere definite), noi autistici e autistiche siamo state studiate, catalogate, osservate e giudicate in base a due punti di vista che mostrano chiaramente un pregiudizio: o come esseri difettosi e bisognosi di cure, di interventi per diventare il più “normali” possibile secondo un modello medico riabilitativo, oppure in base alla nostra capacità produttiva, alla performance lavorativa, seguendo un modello economico.
Il problema con entrambi questi approcci è che non considerano il punto di vista delle persone che studiano e catalogano, e per le quali legiferano e prendono decisioni politiche, mediche ed economiche dalle ricadute estremamente pesanti sulla loro vita. Il cosiddetto modello sociale invece propone l’idea che una persona non viva in un vuoto pneumatico ma la sua esistenza sia il risultato dell’interazione con la società, e se questa società “disabilita” la persona ponendo sul suo cammino una serie di ostacoli e barriere, allora essa diventa parte del problema e dovrebbe quindi essere parte della soluzione.
La creazione di un’identità di gruppo è importante per la rivendicazione di diritti e opportunità a volte basilari che, senza il contributo culturale di un gruppo socialmente identificabile, continuerebbero a essere concessi in una serie di atti paternalistici, gettati dall’alto, donati con condiscendenza a chi continuerebbe a essere visto come inferiore, guasto, non necessario dal punto di vista produttivo, economico.
La prevalenza dello sguardo medico ed economico nella narrazione collettiva dell’autismo è ciò che impedisce alla voce delle persone autistiche di acquisire pari dignità rispetto alle altre, come ad esempio quella degli specialisti, proprio perché se siamo creature difettose, anormali, non conformi in senso negativo, allora non possiamo sapere cosa sia meglio per noi, e ovviamente non veniamo ritenutǝ capaci di indirizzare le politiche sociali ed economiche che dovrebbero contribuire ad abbattere barriere.
Chiariamoci, nemmeno a me piace l’idea di appartenere a una “minoranza” e fa bene chi sostiene che le etichette andrebbero abolite, e che le minoranze non esisterebbero se si riuscisse a comprendere che siamo tuttǝ diversǝ. Il problema è che, prima di poter eliminare le minoranze, bisognerebbe abolire l’etichetta più problematica, la minoranza più potente e intransigente, quella che si definisce maggioranza e che per adesso detta le regole politiche, economiche e sociali e dà forma alla società nella quale viviamo, mantenendo in piedi barriere di ogni tipo. E continuerà a farlo senza delle minoranze che siano in grado di far ascoltare la propria voce, la propria versione della storia, la propria cultura.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la ricerca[1]. Se si continua a seguire il modello medico riabilitativo o quello economico, se insomma noi autistiche e autistici siamo viste come inferiori, difettose, economicamente inutili, anche gli obiettivi che si porrà la ricerca scientifica continueranno a essere dettati dallo sguardo della maggioranza. Gli studi e gli esperimenti mireranno quindi a confermare deficit, a cercare le cause di difetti, a domandarsi come curare o come prevenire quella che, da questo punto di vista, continua a essere vista come una patologia da estirpare.
L’influenza delle persone autistiche deve diventare fondamentale nel determinare gli obiettivi della ricerca. Non possiamo esser parte della ricerca solo in quanto oggetto di studio, ma dobbiamo partecipare anche al disegno degli esperimenti, decidere insieme alle altre persone quali direzioni far prendere alla ricerca. Un esempio lampante di quanto questo cambiamento sia necessario è quello della Teoria della Mente e dell’empatia autistica.
Quando Simon Baron-Cohen ha deciso di studiare la Teoria della Mente autistica (la capacità di attribuire stati mentali e sensazioni a se stessi e agli altri) l’ha fatto da una prospettiva deficitaria. Il suo scopo è stato capire dove risedesse il deficit, in che modo noi autistiche e autistici siamo carenti in quell’area. E ne è nata l’idea che le persone autistiche non siano empatiche.
Ma è stato proprio un punto di vista errato a creare una teoria falsa, che ha aggiunto un altro stigma a una categoria già pesantemente stigmatizzata; sono stati un punto di partenza fazioso, degli obiettivi distorti e una metodologia[2] tarata su un funzionamento non compreso appieno a farci diventare deficitari anche nell’empatia. E questo errore continua essere rimbalzato da una narrazione affezionata all’idea che la non conformità alla maggioranza debba essere necessariamente difettosa, inferiore, carente.
Solo quando la questione è stata posta senza il pregiudizio dello sguardo deficitario e patologizzante, solo quando a studiare l’empatia autistica ci si è messo Damian Milton[3], ricercatore autistico, ne è nata una teoria sensata che vede nella reciprocità (parola da utilizzare più spesso) il problema: non siamo noi persone autistiche a essere carenti di empatia, è un problema reciproco. Noi abbiamo difficoltà a comprendere le persone neurotipiche, e loro a comprendere noi neurodivergenti, questione di codici e interpretazioni differenti. Un cambiamento di prospettiva tutto sommato banale ma irraggiungibile senza il contributo diretto della minoranza oggetto di studio.
La formazione di una cultura autistica, di un gruppo con un’identità data da una visione del mondo differente, è quindi fondamentale proprio per aiutare la società a comprendere le istanze, le aspirazioni e le necessità di quel gruppo. L’appartenenza culturale è importante anche nella formazione di un’identità personale che non passi attraverso la lente distorcente che crea insicurezza, senso di inferiorità e di inutilità in tante persone autistiche. Perché senza una cultura di riferimento si cresce pensando di non essere abbastanza, si crede che manchi sempre qualcosa per poter essere come gli altri; si vive con la convinzione di dover fare costantemente di più, perché il proprio modo di essere è sbagliato.
NOTE
[1] Hahn, H. (1993). The Political Implications of Disability Definitions and Data. Journal of Disability Policy Studies, 4(2), 41–52.
[2] Gernsbacher, M. A., & Yergeau, M. (2019). Empirical Failures of the Claim That Autistic People Lack a Theory of Mind. Archives of scientific psychology, 7(1), 102–118. doi:10.1037/arc0000067
[3] Milton, D. E. M. (2012). On the ontological status of autism: the “double empathy problem.” Disability & Society, 27(6), 883–887. doi:10.1080/09687599.2012.710008
Se ti interessa il liguaggio della diversità, ti consiglio il mio nuovo libro: In Altre Parole, dizionario minimo di diversità