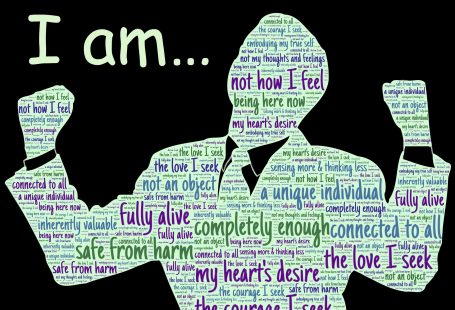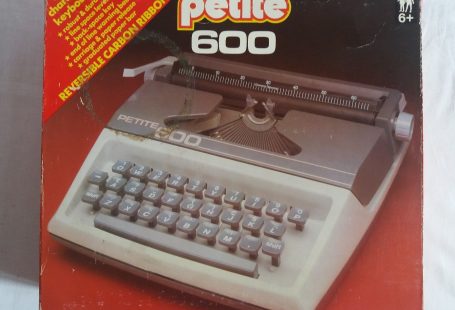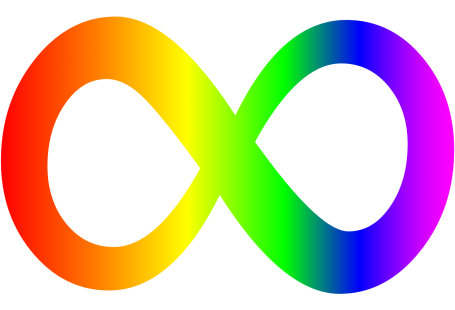Tutto dipende dal punto di vista. Un po’ come la vignetta che ritrae due persone, una di fronte all’altra, che osservano un bicchiere pieno per metà: per una è mezzo pieno, per l’altra mezzo vuoto.
Tutto dipende dal punto di vista. Un po’ come la vignetta che ritrae due persone, una di fronte all’altra, che osservano un bicchiere pieno per metà: per una è mezzo pieno, per l’altra mezzo vuoto.
Oggi il punto di vista rispetto alla diversità sta lentamente cambiando. Forse la trasformazione è cominciata con la creazione del cosiddetto modello sociale della disabilità nell’Inghilterra degli anni ‘70, che si è contrapposto a quello classico di stampo medico. Secondo il modello medico la disabilità è una caratteristica della persona, secondo quello sociale invece essa è il prodotto di un’interazione dissonante tra quella specifica caratteristica e una società costruita da e per persone che sotto quell’aspetto sono differenti. In pratica, se ho una gamba invece di due, il modello medico dirà che ho un difetto, un deficit, e giudicherà quella caratteristica come disabilità, come qualcosa che mi rende inferiore alla media e va riparata, per quanto possibile. Questo avviene anche perché in precedenza è stato attribuito un valore positivo all’ideale (artificiale) di “abilità” media.
Per il modello sociale invece quella caratteristica non è di per sé una dis-abilità, una mancanza di abilità, ma lo diventa quando mi trovo a interagire con un mondo creato per persone che di gambe ne hanno due. È quindi la società a disabilitare la persona. Questo cambio di punto di vista è fondamentale sia perché permette un’attribuzione più equa delle responsabilità nelle difficoltà quotidiane di alcune persone, sia perché ci dice che nella nostra specie (come in ogni altra) è naturale una enorme variabilità delle caratteristiche fisiche, sensoriali, neurologiche, mentali. Inoltre tali differenze, anche se in alcuni casi racchiudono delle difficoltà, non sono di per sé un difetto ma lo diventano quando vengono messe a confronto con un ideale artificioso di normalità.
Questo modo di osservare il mondo può essere applicato non solo alla disabilità, ma a qualsiasi caratteristica differente da una norma stabilita arbitrariamente da alcune persone per catalogarne altre. Vale per la cultura di appartenenza, per il luogo d’origine, il colore della pelle o dei capelli, vale per l’oggetto o gli oggetti verso cui manifestiamo o meno attrazione sessuale; vale per la religione, per il genere e per il modo in cui ci identifichiamo in esso, o per le idee politiche. Vale per il modo in cui socializziamo, per la modalità con cui ci esprimiamo, per l’attenzione che riusciamo a sostenere.
Il mondo del lavoro non fa eccezione: se non rientri in quella che è la “norma” lavorativa, non sei adatta e vieni scartata. Leggiamo ancora oggi annunci che, per un impiego d’ufficio in un’agenzia dell’Unione Europea, richiedono una persona “fisicamente adatta” (cosa che, è scritto, verrà verificata con apposita visita medica). Ma non è necessario arrivare a obbrobri come questo, basta leggere le caratteristiche abitualmente richieste nella maggioranza delle offerte di lavoro per capire quanto questo ambito sia oggi ancora lontano dal rispecchiare la naturale diversità presente nella nostra società.
Ancora vengono richieste figure mitologiche come i “team player”, o persone che abbiano il desiderio di “superare le aspettative”. Annunci in cui si cercano persone dinamiche, intraprendenti e con spirito d’iniziativa (che in inglese si riesce a infilare in una sola parola: proactive), con “sviluppate competenze sociali”, ma anche “intraprendenza, umiltà, tenacia, creatività, spirito di sacrificio, precisione”.
Cosa accade a chi non possiede determinate caratteristiche? È presto detto: poiché l’impiegato ideale non esiste ma è frutto di un processo di standardizzazione e generalizzazione innaturale, allora fingiamo. Ciascuna di noi, nessuna esclusa, ogni persona finge. Certo, c’è chi finge di più e chi meno, c’è chi è naturalmente “team player” e chi deve far finta di esserlo; ci sono persone che davvero si divertono alle cene aziendali, o che posseggono una spinta alla competizione che in casi estremi permette loro di passare sopra a chiunque, e a qualsiasi dilemma etico. Ma difficilmente in una stessa persona troveremo tante di quelle caratteristiche.
Si finge, sul lavoro, si finge di riuscire a reggere i ritmi sempre più accelerati, una videocall dopo l’altra e sempre sorridendo perché bisogna sorridere, occhio alle competenze sociali. Si finge entusiasmo anche quando ci ha abbandonato da un pezzo, e dire che ce l’avevamo messa tutta. Si finge amabilità e cortesia anche quando vorremmo distruggere il mondo con un lanciafiamme. Si finge di essere “resilienti”, anzi no, oggi si finge di essere “antifragili” perché la naturale fragilità umana è anch’essa divenuta una caratteristica indesiderabile. E alla fine, per chiunque, il burnout è dietro l’angolo.
Ovviamente, a seconda di quanto ti allontani da quell’ideale irraggiungibile di impiegato perfetto o di manager carismatica, efficiente e indistruttibile, dovrai fingere di più. E più fingerai, più le tue energie si consumeranno rapidamente e ti avvicinerai all’esaurimento, al burnout. In poche parole, più sei diversa, o diverso, più vivrai nel terrore di essere stigmatizzata, additata come quella inefficiente, come il collega incapace di fare alcune cose oppure l’asociale, quella col carattere di merda, o il tipo troppo sensibile che va in crisi per nulla. Più le tue caratteristiche si allontanano da quell’ideale e più cercherai di compensare, perché se vivi in un ambiente in cui quelli come te sono difettosi, inferiori, allora comincerai a crederci anche tu. Ma costringersi a essere chi non si è, stanca, e lo sappiamo.
Affrontare la questione della diversità sul lavoro va ben oltre i training e le giornate a tema, e va ben oltre quelle categorie nelle quali abbiamo deciso di ingabbiare una cosa tanto inafferrabile come la diversità stessa. Parlare di inclusione delle differenze vuol dire partire dal presupposto che non esiste una persona uguale all’altra, e che ogni passo verso una apertura alla diversità, a partire da quella più evidente, si tradurrà in un miglioramento per tutte le persone, a prescindere dalle loro caratteristiche. Ma per riuscirci è fondamentale cambiare il punto di vista e smettere di attribuire un valore qualitativo e morale alle caratteristiche delle persone.
Il limite delle categorie – tra cui anche quella della “normalità” – in cui infiliamo le persone, è che funzionano esclusivamente se l’osservatore è distante dall’oggetto che osserva, insomma, se si rimane nell’ambito della generalizzazione. Più si avvicinerà all’oggetto di osservazione, più si accorgerà che le differenze sono maggiori delle similitudini. Il problema non sono nemmeno le etichette in sé, che ci servono a ordinare il caos del mondo, ma il valore che attribuiamo loro.
È questo, il cambiamento culturale indispensabile alla base dell’inclusione, anzi, della necessaria convivenza attiva e responsabile di tutte le differenze.
 Se ti interessa il liguaggio della diversità, ti consiglio il mio nuovo libro: In Altre Parole, dizionario minimo di diversità
Se ti interessa il liguaggio della diversità, ti consiglio il mio nuovo libro: In Altre Parole, dizionario minimo di diversità