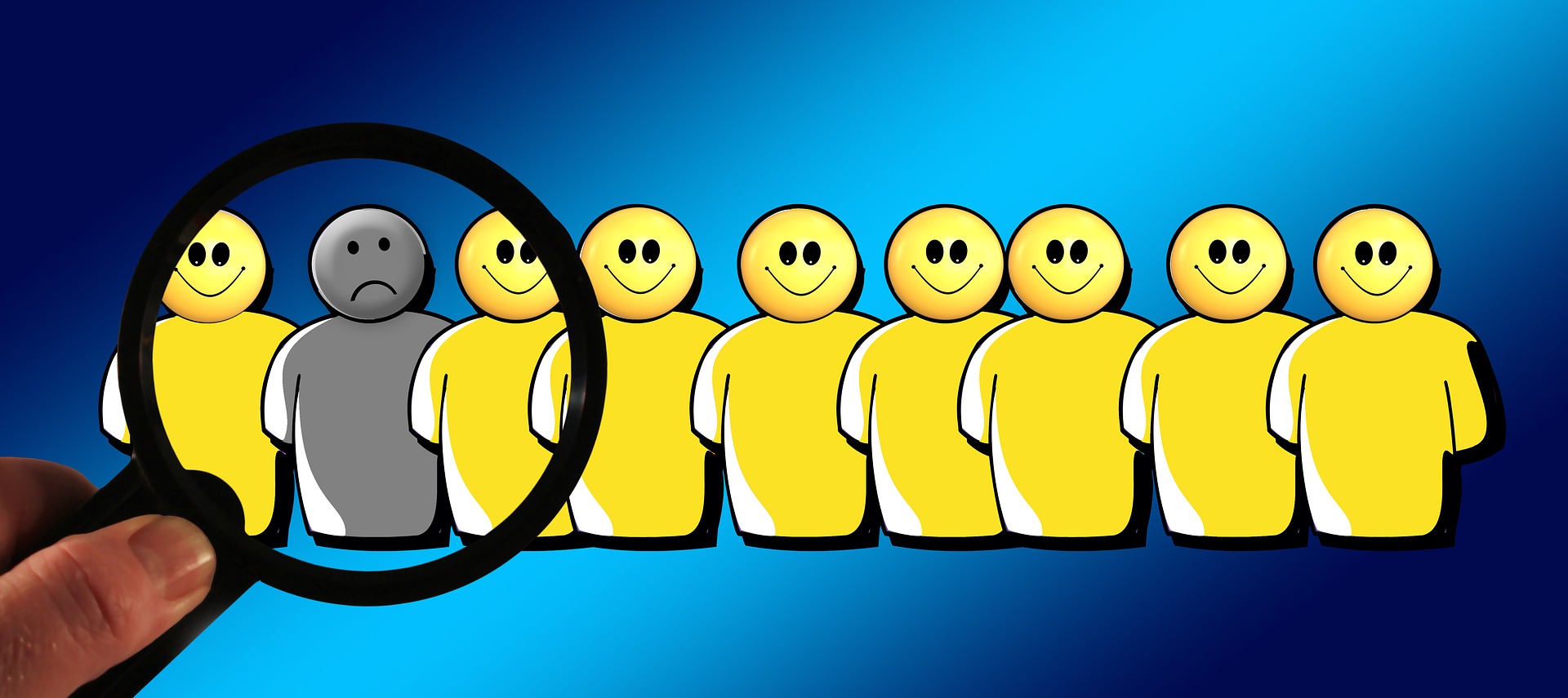La scuola ha un suo odore, lo riconoscerei anche entrandoci bendato. La scuola odora di matite e carta, di umanità e detergenti per i pavimenti. Per me, però, la scuola odora di ansia e solitudine.
La scuola ha un suo odore, lo riconoscerei anche entrandoci bendato. La scuola odora di matite e carta, di umanità e detergenti per i pavimenti. Per me, però, la scuola odora di ansia e solitudine.
Ieri mattina, dopo molto tempo, sono entrato in una scuola superiore, volevano mostrarmi il laboratorio di musicoterapia e farmi fare una chiacchierata informale coi compagni di classe di un ragazzo autistico. Bene, mi sono detto, è giusto sensibilizzare i giovani sulla necessità di includere le persone che possono percepire come differenti da loro, bisogna cominciare proprio dai giovani.
Varcare la soglia dell’istituto è stato traumatico. Sono ritornato ai miei 15 anni, improvvisamente ho provato un timore paralizzante, il desiderio di nascondermi da tutti quei ragazzi e ragazze che camminavano per i corridoi; mi sono sentito squadrato, analizzato ai raggi x dagli insegnanti. È stato un tuffo in un passato al quale, in quel momento, non capivo come sia riuscito a sopravvivere.
Poi, insieme alla docente che mi accompagnava, siamo entrati nell’aula di musica e la situazione è precipitata.
“Dai, vieni a suonare con noi, forza!” mi ha intimato con tono amichevole la musicista che dirige l’orchestra. Io mi sono immediatamente irrigidito. Partecipare? Non vi conosco, io non voglio partecipare a un bel niente, voglio starmene per conto mio, ho pensato mentre biascicavo: “Grazie, preferisco stare qui ad ascoltare…”.
“Ascoltare???” ha detto lei, sgranando gli occhi.
“Sì, resto qui, grazie”.
“Noooooo… tu dopo vieni a suonare con noi, non puoi restare lì”. E ha cominciato a dirigere il gruppo di ragazzi.
Ecco, in quel momento ho vissuto, non ricordato, ma vissuto come se avessi realmente 15 anni, l’odio verso quelle costrizioni incomprensibili, quella socialità imposta a tutti i costi perché se lo fanno gli altri, i “normali,” allora devi farlo anche tu. Socializzare è bello, è giusto, non vorrai mica insinuare il contrario?
Mentre i ragazzi suonavano ero lì che cercavo scappatoie. Io non volevo suonare uno strumento qualsiasi, non mi interessava prendere un tamburello e unirmi al gruppo giusto perché dilaga questa mania della la socializzazione a ogni costo. Io suono il pianoforte e il clavicembalo, e soprattutto suono quando lo dico io, mica a comando! Ero lì che mi inalberavo in un monologo interiore dai toni sempre più accesi, il cuore aveva ormai cominciato a mitragliarmi nel petto nell’attesa che finisse il brano musicale e qualcuno mi mettesse in mano un tamburello o un paio di sonagli, quando la musica si è fermata. Panico.
La docente che mi accompagnava ha posato i sonagli con cui stava partecipando (lei sì, si divertiva) e ha salutato. Dobbiamo andare, ci aspettano in classe tra poco e dobbiamo parlare, ha detto alla direttrice d’orchestra. Saluti, ringraziamenti. E siamo usciti.
Pericolo scampato, ho pensato con una sensazione di sollievo indescrivibile.
Prendiamo un caffè al bar, mi ha detto. 10 minuti prima dell’inizio dell’intervallo. Al bar i panini avvolti nella plastica, riposti in contenitori di plastica e poggiati su dei tavoli rivestiti di plastica. Mi è tornato in mente il banchetto dei panini a scuola, da ragazzo. Panini di plastica, una cosa orribile, potevi masticarli per ore ma niente, non perdevano quella consistenza gommosa e ti rimbalzavano nello stomaco per ore. Però mi piacevano, forse perché il momento dell’intervallo significava che eravamo ormai a metà di quel supplizio quotidiano.
Il suono della campanella mi ha trapanato i timpani. Gli studenti sono usciti urlando dalle loro classi, decine, centinaia di ragazzini che gridavano, scherzavano tra loro, giocavano. E io seduto al tavolino, cercando di ritrovare l’invisibilità che avevo sviluppato con tanta fatica durante gli anni di scuola.
La docente continuava a parlarmi ma ormai ero nel pallone. Tra le luci al neon, le urla degli studenti che rimbombavano sulle pareti spoglie del salone e l’ansia che mi si portava via, ormai non capivo una sola parola di quello che mi diceva.
Tornare a scuola, rivivere dopo esattamente 30 anni l’incubo quotidiano dell’esclusione. Calmati, mi sono detto, non è come quando eri ragazzo, adesso non sei più uno di loro. No, adesso non sono più uno di loro ma il problema, la causa di tanta ansia, dell’emarginazione, del non avere amici tra tanti coetanei, è proprio che io nemmeno a 15 anni ero uno di loro.
Quanto tempo della mia vita trascorso sopportando, fingendo, cercando di capire come fare per assomigliare a loro. Quanti anni pensando: “Dai, manca poco, ancora tre, due anni e sarà finita”, cercando di passare inosservato perché se non potevo essere uno di loro almeno speravo che non si accorgessero di me. Anni pregando in un’esplosione notturna, in uno sciopero, in qualsiasi cosa potesse tenermi fuori da quel luogo almeno per un giorno.
Eppure ieri, nonostante questo tuffo violento in un passato che ho cercato invano di dimenticare, mi sono accorto di una differenza enorme con la scuola dei miei tempi: quei ragazzi la diversità la conoscono già e la accettano con una naturalezza stupefacente. Il compagno di classe autistico è uno di loro, si vedeva chiaramente che gli vogliono bene, che lo proteggono. Quei ragazzi ascoltavano le mie parole con attenzione ma la storia già la conoscevano: siamo tutti diversi, è giusto così, la diversità non è una cosa negativa o positiva, semplicemente c’è.
Parlando a quella classe ho provato invidia per il ragazzo autistico. Ho immaginato per un attimo come sarebbe stata la mia adolescenza in una classe come quella, sentirmi accolto e addirittura protetto dai miei compagni di scuola, sapere che la mia diversità non è motivo di scherno.
Forse qualcosa sta cambiando, ho pensato. Probabilmente noi adulti dovremmo dare più fiducia ai giovani, potremmo imparare molto da loro, perché mi sa che tanti dei pregiudizi che ci sono in giro siamo proprio noi, a metterglieli nella testa.