
Si parla di neurodiversità per indicare la variabilità neurologica tra le persone; neurodiversità come omologo neurologico di biodiversità.
Si definiscono quelle condizioni in cui il sistema nervoso è organizzato in modo differente dalla media della popolazione come “neuroatipicità“. Non malattie, non condizioni caratterizzate da deficit ma da differenze. Portare fuori dallo sguardo medico determinate realtà ha lo scopo di restituire dignità alla persona, di non farla sentire inferiore. Guardare all’autismo e alle altre condizioni di diversità neurologica come a differenti modalità di percezione ed elaborazione della realtà e di interazione col mondo non è soddisfare un capriccio: è un atto dovuto, una questione di civiltà. È riconoscere che le differenze tra le persone non possono essere motivo di giudizio, che nessuna andrebbe costretta o anche solo spinta dalla pressione della società a diventare diversa da chi è nella realtà.
Riconoscere il differente funzionamento neurologico di alcuni senza attribuire a queste differenze un valore (spesso anche morale), è fare realmente inclusione: un processo in cui la relazione tra le parti è da pari a pari e non da migliore a migliorabile, o da perfetto a difettoso, o da fortunata a povera disgraziata.
Prendere atto delle diverse possibilità con cui noi umane e umani possiamo interagire, comunicare, muoverci nel mondo senza volere per forza trovarne una migliore delle altre, apre la società a infinite opportunità di cambiamento. L’evoluzione della nostra cultura, la ricchezza di pensiero che le civiltà hanno raggiunto nei secoli e trasformato spinte dal desiderio di sapere e dalla necessità di poter vivere meglio, sono frutto della diversità delle menti che hanno contribuito a creare e a scolpire queste culture.
Voler ridurre le differenze a difetti non è solo un atto dichiarato di superbia, ma è sciocco e pericoloso perché è come voler eliminare dal mondo il concetto di biodiversità: non è possibile, la biodiversità è una realtà.
Parlare e scrivere di neuroatipicità non è quindi un vezzo superficiale, un tentativo di imbellettare la realtà, ma è mettere in pratica un cambiamento culturale concreto che ha una ricaduta altrettanto concreta sulla vita di molte persone. È riconoscere che il nome che diamo agli esseri viventi e alle cose, le categorie che creiamo per navigare nella realtà, si trasformano poi in fatti, in leggi e regolamenti, in maggiore o minore dolore per alcune, in maggiore o minore serenità per altre.
Quelle che alcuni definiscono “solo” parole, hanno la curiosa tendenza a diventare fatti.
Comprendere che possano esistere modalità di funzionamento differenti da quella che abbiamo sempre immaginato come l’unica possibile, e che ciascuna di esse debba essere trattata con pari dignità e abbia diritto a pari opportunità nella nostra società, è difficile perché presuppone la rinuncia al potere che una sola modalità di funzionamento si è attribuita sulle altre per molto tempo. Pari dignità, pari opportunità, sospensione di qualsiasi giudizio di valore e morale nei confronti dei funzionamenti differenti vuol dire scendere dal piedistallo della superiorità su cui ci si è trovati per un puro caso e rendersi conto che la società è formata da una quantità di differenze enorme, e che ciascuna di noi può essere uguale o diversa a seconda di quale caratteristica si scelga arbitrariamente per misurare l’uguaglianza o la diversità.
In poche parole: differente non vuol dire inferiore, difettoso, sbagliata. Non riconoscerlo equivale a porsi automaticamente in una posizione di superiorità e non voler ascoltare le ragioni dell’altra.
Un po’ come continuare a insistere sulla storia del contatto oculare nell’interazione con noi autistiche e autistici.
Ritenere importante costringere una persona a guardarvi negli occhi quando parla con voi vuol dire: «Qui comando io, a casa mia esiste solo una modalità di interazione, e questa prevede che quando comunichiamo ci guardiamo negli occhi. Se non lo fai, IO mi sentirò a disagio, IO non riuscirò a stabilire un contatto adeguato secondo la MIA modalità di comunicazione di default (che essendo la mia, è l’unica giusta)».
Insistere sul contatto oculare significa non prendere minimamente in considerazione la possibilità che un gruppo di persone con un funzionamento neurologico differente possa vivere quel gesto, il contatto oculare, in modo completamente opposto. Forzare un cambiamento in tal senso è la dichiarazione di superiorità di una modalità di funzionamento neurologico sull’altra. E poco importa che tantissime autistiche abbiano provato a spiegare che il contatto oculare può generare ansia, che per guardare negli occhi l’interlocutore ci si distrae e non si ascolta ciò che dice, che guardare altrove non è segno di disinteresse ma, al contrario, di concentrazione. Alla fine, quando si forza una persona a cambiare, anzi a “migliorare”, come ho spesso tristemente letto o ascoltato, le si sta dicendo che è inferiore, guasta, difettosa. E basta.
Fornire a chi è differente le istruzioni per comprendere il funzionamento neurotipico è una cosa utile, ed è completamente diverso dal costringere una persona neuroatipica a funzionare in modalità neurotipica. La differenza non è poi così sottile, direi che è estremamente visibile. Dialogare con gli autistici e le autistiche per fare in modo che ciascun gruppo comprenda il funzionamento dell’altro, per apprendere ciascuna la lingua dell’altra nel rispetto delle caratteristiche di tutte, è l’unica inclusione possibile. Tutto il resto, è un’altra cosa.



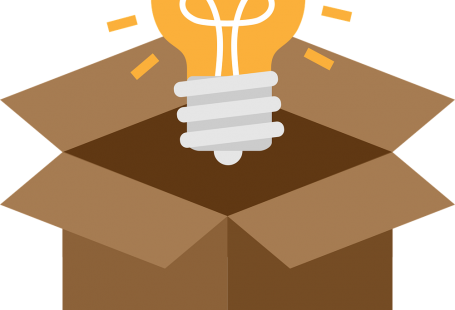

2 comments On Da pari a pari
Ciao! Sono autistica e seguo sempre il tuo interessantissimo blog, trovo sia ricco di riflessioni e approfondimenti su temi ancora così lontani dalla mentalità delle persone che non conoscono l’autismo. A proposito del tuo ultimo articolo (che condivido al 100%), vorrei chiederti cosa pensi del libro “Le regole non scritte delle relazioni sociali” di Temple Grandin e Sean Barro, che non ho ancora letto ma di cui mi è stata consigliata la lettura. L’espressione “regole” del titolo veramente mi spingerebbe ad allontanarmi da un simile testo: chi ha stabilito queste “regole”? Chi ha detto che vadano bene per tutti? E in quale cultura queste “regole” sono state decise, in quale parte di mondo? Mi piacerebbe sapere la tua opinione in proposito, nel caso tu conosca già questo libro. Grazie mille!
Ciao! Scusa se non ho risposto prima. La verità è che non conosco il libro, ma mi hai incuriosito molto. Io non mi lascerei scoraggiare dal titolo, piaccia o no le regole esistono e sono parte del nostro vivere sociale. Comprendo quello che dici in relazione al “chi l’ha deciso” e lo condivido, ma credo che forse valga la pena dare una chance al libro…