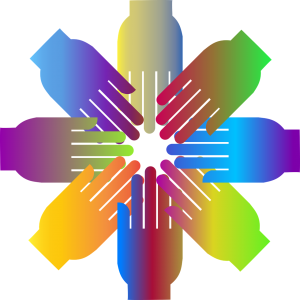 Ieri è nata su Twitter l’ennesima discussione sul concetto di neurodiversità che ha evidenziato, come sempre, la polarizzazione di opinioni tra genitori di persone autistiche e alcuni autistici e autistiche adulte. La discussione è nata a seguito della lettura di un articolo in cui in modo confuso e con una certa dose di benaltrismo, il concetto di neurodiversità veniva interpretato (in modo forse consapevole) come voler negare le difficoltà e la possibile disabilità associata a una condizione come l’autismo e, addirittura, a viverla come un dono o un “superpotere”, come effettivamente alcuni personaggi anche piuttosto noti hanno definito certe loro caratteristiche.
Ieri è nata su Twitter l’ennesima discussione sul concetto di neurodiversità che ha evidenziato, come sempre, la polarizzazione di opinioni tra genitori di persone autistiche e alcuni autistici e autistiche adulte. La discussione è nata a seguito della lettura di un articolo in cui in modo confuso e con una certa dose di benaltrismo, il concetto di neurodiversità veniva interpretato (in modo forse consapevole) come voler negare le difficoltà e la possibile disabilità associata a una condizione come l’autismo e, addirittura, a viverla come un dono o un “superpotere”, come effettivamente alcuni personaggi anche piuttosto noti hanno definito certe loro caratteristiche.
È una dinamica comune che va oltre la diatriba sulla neurodiversità, e si ripete in diversi ambiti in cui esista una minoranza che percepisce se stessa come oppressa e una maggioranza che non vuole concederle questo status. Semplificare concetti complessi che cercano di spiegare realtà estremamente variegate e sfumate, attribuire scopi o ideali a gruppi o movimenti che spesso nella realtà nemmeno esistono, creare l’idea terrificante che sostenere la diversità e le naturali differenze tra esseri umani sia voler minimizzare le difficoltà di alcune persone, o che porterà a una sorta di dittatura delle minoranze: tutti questi sistemi vengono usati anche per screditare la discussione sull’identità di genere o sull’orientamento sessuale, ad esempio.
Nel caso dell’autismo, fondamentalmente accade che alcuni genitori e familiari di persone autistiche in maggioranza di livello 2 e 3, ossia con limitata indipendenza e con una serie di difficoltà che impediscono loro di avere quella che può essere considerata una “vita normale”, si scontrino con alcune persone autistiche, la maggior parte – ma non esclusivamente – di livello 1, le quali sostengono il diritto di autorappresentanza e di autodeterminazione e una visione non patologica della propria condizione.
E in effetti il problema non è proprio insignificante, perché da un lato ci sono persone che accudiscono figlie e figli non indipendenti e che quotidianamente soffrono per l’impossibilità dei loro figli di interagire col mondo come fa la maggioranza. Si tratta di genitori che devono affrontare problemi pratici e reali che vanno dal dover assistere costantemente le proprie figlie e i propri figli per i compiti più elementari ed essenziali, al pensiero costante e stremante del “che accadrà quando noi non ci saremo più?”.
Dall’altra parte ci sono persone, per lo più adulte e che in maggioranza si esprimono verbalmente, che dal 2013 si ritrovano a condividere una stessa diagnosi di autismo con individui dalle caratteristiche anche molto differenti in alcune aree. Eppure la comunità medica si è pronunciata in questi termini: l’autismo è uno, le manifestazioni principali di questa condizione sono comuni tanto a coloro che necessitano di supporto continuo e non si esprimono come la maggioranza, quanto a chi fino al 2013 riceveva una diagnosi di sindrome di Asperger. Secondo il DSM-5 e ormai anche l’ICD-11, i due manuali di riferimento utilizzati dalla comunità medica per diagnosticare l’autismo, si tratta di uno spettro che racchiude una estrema variabilità al suo interno e in cui le caratteristiche con cui si manifesta variano in quantità e in intensità da persona a persona.
E così due gruppi che potrebbero unirsi con un obiettivo comune, ossia battersi per un miglioramento delle condizioni di vita e dei diritti delle persone autistiche, si allontanano sempre più e spesso, troppo spesso, si fanno la guerra. Questa dinamica è comprensibile e nasce da un elemento che in realtà accomuna tutte le persone coinvolte: la frustrazione. Già, inutile girarci intorno, perché qualsiasi movimento emancipativo ha alla base una dose di bellicosità che nasce dal vivere la propria condizione come oppressa, dal sentirsi privare di diritti basilari come quello di autorappresentanza e autodeterminazione, e dirige questo desiderio di riscatto sociale verso il presunto colpevole. Discorso che vale tanto per chi vive una condizione come l’autismo in prima persona e riesce a esprimere i propri pensieri e bisogni, quanto per chi si trova ad accudire persone autistiche che non riescono a farlo, e quindi si fa interprete delle loro necessità e dei loro pensieri.
Come spesso accade per i gruppi marginalizzati, attorno alla minoranza neurodivergente comincia a formarsi un pensiero che lentamente e all’inizio in modo eterogeneo, crea una cultura alternativa nella quale alcune persone si identificano. L’autismo, percepito come una delle tante variazioni possibili della neurologia umana, diventa tratto identitario, e in alcuni casi è vissuto con orgoglio. Esattamente come accade per altre espressioni di quella che possiamo definire diversità.
Dall’altra parte, ci sono le famiglie che vivono quelle situazioni complicate e stancanti descritte in precedenza, famiglie che si preoccupano per le proprie figlie e i propri figli e che soffrono perché percepiscono come minimizzata la difficile condizione in cui si trovano proprio dal cosiddetto “movimento” per la neurodiversità. E con loro ci sono quelle persone autistiche anche di livello 1 che non si rispecchiano in una visione sociale dell’autismo, una visione non patologica che si concentri sulle differenze tra individui, ma che vivono la propria condizione come qualcosa di cui vorrebbero liberarsi.
Entrambi i gruppi sono mossi da ragioni comprensibili, e anche il loro rancore o comunque la diffidenza reciproca è facile da comprendere in quanto nasce proprio da quella frustrazione, dalla rabbia, dalle difficoltà che – per un motivo o per un altro – ciascuno incontra nella propria vita.
Purtroppo è vero, ci sono persone autistiche che sembrano non rendersi conto delle difficoltà che questa condizione può portare con sé, e tale mancanza di obiettività contribuisce a gettare discredito su un concetto, quello di neurodiversità, che potrebbe invece aiutare anche ad affrontare quelle difficoltà e disabilità (quando ci sono) in modo differente. È altrettanto vero però che alcune persone negano la possibilità che oltre alle difficoltà e al dolore, l’autismo possa portare con sé alcune caratteristiche positive. E, più in generale, queste persone negano la possibilità che a prescindere dalle difficoltà un individuo possa riconoscere il proprio modo di essere non come una serie di deficit, ma come l’insieme di caratteristiche e che, come per chiunque altro, esse ne determinino l’identità.
Da questo loop sembra non esserci via d’uscita, ormai lo scontro è aperto e da entrambe le parti ci si chiude sempre più sulle proprie posizioni. Gli animi si infiammano per molto poco, e ciascun gruppo attribuisce all’altro caratteristiche e idee che spesso non corrispondono alla realtà. Le discussioni sono quasi sempre intorbidite e viziate da una caterva di bias che impediscono a ciascuna delle parti di andare incontro all’altra, arrivando spesso a discussioni accese in cui invece di cercare punti in comune, e ce ne sarebbero tanti, ci si insulta a vicenda in modo infantile e irragionevole.
Personalmente, sostengo l’idea di neurodiversità intesa come biodiversità neurologica, come espressione della variabilità neurologica della specie umana. E questo non esclude assolutamente che alcune persone, in questa grande variabilità, possano sperimentare difficoltà dovute a caratteristiche che ne limitino l’indipendenza e la capacità di comunicare in modo chiaro i propri sentimenti e le proprie necessità. Una cosa non esclude l’altra, questo è il punto che sembra sfuggire a entrambe le parti quando si lanciano in offensive a volte prive di logica.
Anche il modello sociale, che tanto viene criticato da molte persone, non nega affatto l’esistenza di caratteristiche che creano di per sé difficoltà o deficit, sarebbe stupido. Tant’è che in inglese si fa differenza tra “disability”, la disabilita che è conseguenza dell’interazione tra un individuo con determinate caratteristiche e una società strutturata da e per persone che ne hanno altre, e “impairment”, ossia la caratteristica che diviene problematica, a volte il deficit, la perdita di una funzione o il non possedere quella caratteristica comune alla maggioranza. La disabilità è un fatto sociale, ma alcune caratteristiche possono essere problematiche a prescindere.
Presi dalla frustrazione di situazioni personali, dall’orgoglio ferito, dal comprensibile dolore che in certi momenti può emergere nelle nostre vite, non ci rendiamo conto che ci stiamo facendo del male a vicenda, che ci stiamo mancando reciprocamente di rispetto, che stiamo travisando il significato di concetti e parole. Non ci rendiamo conto che quelle parole sono in grado di scatenare in chi le riceve delle reazioni anche violente, né ci rendiamo conto che il nostro uso superficiale del linguaggio, il nostro esprimere con leggerezza opinioni personali in contesti pubblici, può contribuire a creare malintesi, a disinformare, a polarizzare il discorso in modo inutilmente divisivo.
Probabilmente sono ingenuo, ma spero ancora che si possa trovare un punto d’incontro, perché alla fine lo scopo è comune: migliorare la vita e i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie. So bene che anche un discorso conciliatore si presta alle critiche sterili di chi attribuisce colpe a una parte sola senza guardare alle proprie responsabilità, ma temo che quelle persone non comprenderanno mai il concetto fondamentale di reciprocità alla base di ogni scambio linguistico, culturale, umano. A prescindere dal gruppo al quale appartengono.




