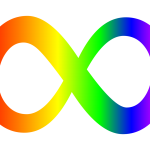La giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo è passata. Da oggi i riflettori che ieri erano puntati sull’autismo si spegneranno di nuovo, e in molti casi è forse un bene. Da oggi ci sarà un po’ meno spettacolarizzazione.
Eppure, dopo tante parole, rimane una sensazione di vuoto; cerco di guardarmi dentro per capire da cosa derivi, se in qualche modo sia io stesso responsabile di questo sentimento di incompiutezza. E, cercando cercando, arriva la risposta.
La giornata di ieri è stata estenuante tra le interviste (non tutte pubblicate), le revisioni dei testi, la diretta che mi ha messo addosso un’ansia tremenda perché a me, di parlare mentre mi guardo in uno schermo e mi riascolto in cuffia, non viene proprio così naturale. E i messaggi, tanti messaggi e commenti a cui rispondere – molti anche piuttosto sgradevoli e infantili – le telefonate e nel frattempo anche un po’ di lavoro per l’università. Fuso, cotto, ma apparentemente soddisfatto. Fino a stamattina.
Perché poi mi sono reso conto che nel trambusto della giornata a tema, in cui il discorso si abbassa a livelli infimi, ho sprecato troppo tempo a leggere articoli pietosi, a irritarmi per definizioni legate ancora all’idea di malattia, di difettoso, di nemico da sconfiggere. E inevitabilmente il mio discorso interiore è rimasto ancorato a quei dettagli, a quegli stupidi stereotipi che nonostante tutto continuano a rimanere il cavallo di battaglia di chi l’autismo non lo capirà mai perché insiste a vederlo solo dal proprio punto di vista.
Ma per stare dietro a simili sciocchezze, per cercare di smentire, commentare, mandare a quel paese l’ennesima persona che mi vede come un puzzle impossibile da decifrare o come un puffo incapace di comprendere il mondo, ho tralasciato quello che a me veramente importa, l’unica cosa che potrà fare la differenza: sottolineare ancora di più l’aspetto culturale di tutta la faccenda.
Sì, perché alla fine il mio discorso è stato così diretto a singoli elementi fuori posto, alle note stonate, che ho dimenticato di mettere insieme i pezzi.
Non c’è consapevolezza senza la comprensione profonda delle differenze culturali. Se urlo ai quattro venti che l’autismo non è una malattia – e continuo a sostenerlo con buone ragioni – devo però anche spiegare che il discorso va ricondotto verso un ambito più profondo e dalle implicazioni assai più potenti di quei criteri diagnostici così mutevoli o dei nastrini blu. Il discorso deve prendere in considerazione l’unica vera soluzione alla enorme maggioranza delle difficoltà che noi autistici (ma tutti i “diversi” in generale) incontriamo nella nostra vita: il cambiamento culturale nei confronti delle diversità.
Ieri, in un passaggio dell’intervista al fatto Quotidiano, ho accennato al problema della concessione di brevi uscite (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza) per controllare meglio le situazioni di crisi. Ebbene, quello non è un problema politico e basta, ma è un problema culturale che investe tanto le istituzioni e la politica, incapaci di comprendere che persone diverse hanno necessità diverse, quanto noi comuni mortali che ci avventiamo come squali su chiunque mostri apertamente di non corrispondere a quegli stereotipi fasulli che imprigionano il nostro pensiero.
E con questo mi riferisco anche a tutte le persone che criticano lo spazio finalmente conquistato da quegli autistici che, come me, riescono a esprimersi senza grossi problemi perché non rappresenterebbero chi ha difficoltà più evidenti, o perché incapaci di comprendere il vero dolore delle famiglie con autistici con maggiori difficoltà e una maggiore compromissione di alcune abilità. Anche loro, che sono spesso familiari di autistici, sono ancora vittime degli stereotipi sull’autismo e non si rendono conto di quanto controproducenti siano certi discorsi. Noi che “parliamo”, possiamo spiegare molte delle tantissime cose che abbiamo in comune con gli autistici che potremmo definire più “gravi”.
Comprendiamo il funzionamento di una sensorialità fuori controllo, di una differente modalità sociale, comprendiamo i problemi alla base di un funzionamento particolare delle funzioni esecutive. Certo, noi comunichiamo, esteriormente sembriamo “normali”. Ma io mi chiedo quante di queste persone, che dovrebbero solidarizzare con noi perché portiamo avanti le istanze di TUTTA la comunità autistica e quindi anche dei loro figli, sanno cosa proviamo noi quando siamo fuori dagli sguardi degli altri?
Io, come tanti altri, soffro e ho sofferto per la discriminazione e l’esclusione, per aver finto per anni di essere quello che mai sono stato, per aver dovuto nascondere difficoltà enormi in modo da mantenermi a malapena a galla a scuola e nel lavoro. Ma se la società fosse stata aperta ad accogliere le differenze invece di cercare quando possibile di appiattirle, o di compatirle quando esse sono troppo profonde, forse avrei sofferto di meno.
E quante difficoltà in meno incontrerebbero quelle persone tanto differenti rispetto alla maggioranza, quegli autistici che non possono comunicare, che hanno delle stereotipie così evidenti da non poter essere messe a tacere nemmeno dopo anni di addestramento, se il mondo non li guardasse come dei casi persi ma li accogliesse senza stare lì a emettere etichette di “funzionamento” o di “utilità” sociale.
Già, eccolo lì, il senso di insoddisfazione con cui mi sono svegliato stamattina. Tanto lavoro per spiegare che il linguaggio appropriato è fondamentale, che il blu è solo uno dei colori nello spettro. Tanti articoli per raccontare quanto siano importanti le parole e quindi vadano usate con attenzione, quanto le etichette possano essere utili solo se private di quel giudizio morale che spesso le accompagna, e poi proprio ieri non ho insistito a dovere sulla parte più importante.
Perché il linguaggio va curato? Perché spendere tante parole sulle parole? Perché l’unico modo per aiutare un autistico e chiunque venga escluso dalla società o trattato come un peso da sopportare, è cambiare il nostro modo di vedere il mondo. Cambiare quella cultura che crede di essere l’unica possibile mortificando e umiliando qualsiasi alternativa.
L’unico modo di includere è smettere di pensare che ci sia qualcosa da includere perché in realtà quella cosa è già dentro, è parte del tutto.
Lo dico oggi, perché l’autismo non va in vacanza il 3 aprile. Il linguaggio è importante, è fondamentale perché modella i pensieri e quindi la realtà, dà forma alla società nella quale viviamo. Il linguaggio crea le culture, e le culture possono essere autoritarie e tiranniche, possono escludere e annientare le differenze o, al contrario, vivere una nell’altra, fondersi tra loro e crescere proprio grazie a quelle differenze.
La diversità, che sia neurologica o di qualsiasi altro tipo, non è un pericolo, ma non è nemmeno necessariamente una ricchezza, come a volte in buona fede diciamo un po’ tutti. La diversità è semplicemente la più onesta forma di normalità. E questo discorso vale tanto per i neurotipici come per i neuroatipici.