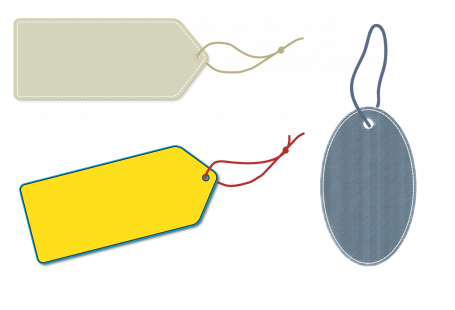Stanotte ho fatto dei sogni nostalgici, situazioni del passato che rimandavano a sensazioni piacevoli.
L’ho già detto, la mia modalità cognitiva preferenziale è molto legata alle immagini sensoriali così, quando alcune sensazioni si presentano accompagnate da fotografie così realistiche in cui sono coinvolti più sensi, come capita spesso nei sogni, l’effetto al risveglio è dirompente.
Stanotte, tra le varie situazioni e persone che hanno popolato la mia realtà onirica, ho sognato mio padre. Era da tempo che non succedeva, molto tempo. È stato un sogno intenso e bello perché, da quello che adesso ricordo, era uno di quei momenti in cui riuscivamo a stare bene insieme, e non capitava proprio spesso.
Al risveglio la tristezza è stata tanta, e anche la sensazione di vulnerabilità, quando dopo qualche secondo ho realizzato che ormai da anni mio padre non c’è più, che a differenza di tante persone intorno a me, io i genitori li ho persi da tanto tempo. In momenti particolarmente complessi come quello che stiamo vivendo, nonostante ormai potrei considerarmi adulto da un bel pezzo, mi mancano tanto. Mi mancano quelle telefonate con mio padre ogni sera, rituale iniziato quando 17 anni fa andai a vivere in Olanda; mi manca l’idea che, se tutto va male, c’è sempre qualcuno da cui tornare, qualcuno che ti aiuterà anche quando continui a fare una cazzata dopo l’altra.
Non riuscivo a spiegarmelo inizialmente, questo sogno così intenso, fino a quando ho letto la data di oggi sullo schermo del computer: 19 marzo. La festa del papà. E sono esplosi i ricordi, immagini vivide di orribili lavoretti realizzati sotto minaccia alle elementari e poesie ancora più atroci recitate mille volte di fila con quella mia acuta cantilena monocorde. Le zeppole di San Giuseppe e poi i primi regali comprati insieme a mia madre, cravatte, un’infinità di cravatte, pennelli da barba mai usati, le coppole e quei bruttissimi borselli di pelle da uomo anni 80.
I pensieri stamattina viaggiano veloci e non ho voglia di fermarli. Almeno loro possono andare lontano, non devono rimanere chiusi dentro la mia testa, non ci sono virus che li costringano a stare confinati in uno spazio tanto angusto. Corrono, i pensieri, e tornano a tutte le ricorrenze che fino a qualche anno fa non potevo non festeggiare. Feste di cui non mi è mai interessato nulla, almeno a livello religioso o culturale, come il Natale o la Pasqua, o capodanno e ferragosto. Feste che, in realtà rappresentavano per me momenti estremamente difficili da gestire a causa delle riunioni oceaniche della mia numerosissima famiglia, gli amici dei miei con figli e nipoti, tutti sistematicamente a casa nostra perché era grande e mamma cucinava bene.
Intimamente detestavo le feste, le odiavo per quella socialità asfissiante e inesorabile, le domande della solita zia indiscreta sulla fidanzatina, l’amico di famiglia che si sentiva spiritoso e ogni anno, fino all’adolescenza, provava a costringermi a recitare una poesia, una qualsiasi, e quanto sei pesante Fabrì, sembri un vecchio, ma non ridi mai? Le feste comandate come quella del papà, il 19 marzo, quando si pranzava tutti e quattro insieme e bisognava indossare l’aria felice anche se la mamma stava male e il figlio era fuori di testa, ma bisognava festeggiare.
Le feste erano il momento più alto di finzione, l’occasione per perfezionare la maschera che per anni e anni quelli come me indossano ogni mattina, quella maschera di normalità costruita e studiata in ogni minimo dettaglio che è più vera della reale normalità, che a volte ti si appiccica addosso e non riesci più a capire dove finisce lei e dove comincia la tua pelle.
E così per anni, dopo essere corso via da casa, lontano migliaia di chilometri da quelle feste obbligatorie e riunioni estenuanti, è rimasta l’abitudine. Un guscio vuoto, una data che ogni anno ritorna sul calendario e richiama automaticamente nella testa la necessità di alcuni rituali. Importanti, i rituali e le routine, fondamentali perché scandiscono il tempo. A Natale bisognava pulire le acciughe, fare l’insalata di rinforzo e gli spaghetti alle vongole, i regali sotto l’albero e il presepe con la cascata vera, un’opera d’arte effimera che, col solito impegno maniacale, io e papà costruivamo e poi smontavamo ogni anno. A Pasqua, in montagna con gli zii e l’odore delle pastiere di mamma che ti impregnava dolcemente l’anima. La festa della mamma era ormai quella data triste del calendario perché lei ormai piangeva tanto, non poteva uscire ed era malata e brutta, lei che da giovane era stata così bella e piena di vita.
Gusci privi di significato ma pieni di ricordi, tanti, vividi ricordi.
Abitudini che continuano a sopravvivere solo nella mia testa anche quando ormai la festa non si celebra più. Comincia quella sensazione, il ricordo si fa strada all’inizio timidamente, aggrappandosi a dei numeri sul calendario, e le emozioni ricominciano a fare a botte nella pancia, il tempo che passa rimescola tutto creando un intruglio dal sapore indefinibile, ora amaro, ora dolce, a volte aspro.

Oggi c’è il sole e immediatamente parte il ricordo di quel 19 marzo in cui prendemmo il camper e andammo in costiera, il portellone aperto come una cornice sul mare e mamma che cucinava sul piccolo fornello; il pacchetto della pasticceria con le zeppole di San Giuseppe sul piano di formica blu. L’odore dell’aglio che soffriggeva in padella, io e mia sorella che corriamo a giocare fuori, l’aria fresca e il profumo del mare.
Ricordi, immagini troppo reali che tornano a galla a orologeria ogni anno, basta guardare quei numeri sul calendario.
E allora oggi, confinato in casa in questa meravigliosa giornata di sole, lascio correre i pensieri verso quei momenti di libertà che rimarranno stampati nella mia memoria fino alla fine.