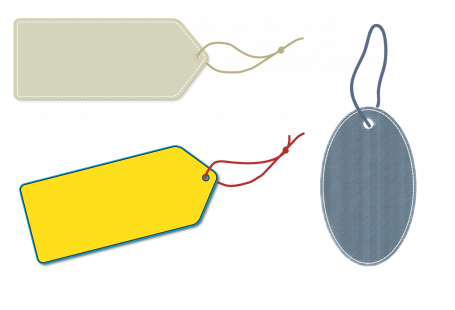2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Consapevolezza non come traguardo ma come punto di partenza, l’inizio di una riflessione che vada oltre la superficie, che metta in discussione le narrazioni convenzionali e si immerga nelle esperienze vissute. La domanda da porsi non è quindi solo “cosa sappiamo sull’autismo?” ma “chi definisce questa conoscenza?“.
La narrazione prevalente sull’autismo si forma nei contesti istituzionali e sui media, ed è espressione di un potere che si manifesta nella forma di un privilegio. È una visione dell’autismo che racconta storie di superamento e riabilitazione che si conformano a un modello di normalità ormai dato per scontato. Questa narrazione che arriva dall’esterno non fa che rafforzare un dialogo unilaterale, in cui la complessità delle esperienze individuali e del vissuto familiare rimangono inascoltate, marginalizzando ulteriormente chi vive l’autismo in prima persona. Un controllo narrativo che agisce in modo simile sulla narrazione di tutte le categorie umane marginalizzate, e sposta la discussione sull’autismo da una comprensione collettiva e accessibile a una definizione ristretta, succube di un riduzionismo scientista che vede la diversità come un problema da correggere.
Mark Fisher definisce “realismo capitalista” la sensazione di ineluttabilità instillata dalla convinzione che non esista alternativa all’attuale sistema capitalista neoliberista, sistema che tende a privatizzare ogni aspetto dell’esistenza umana. Un concetto particolarmente interessante è quello che Fisher definisce “privatizzazione dello stress”, la tendenza delle società contemporanee nel trattare lo stress e le questioni relative alla salute mentale come problemi individuali, piuttosto che come sintomi di questioni sociali ed economiche più ampie. Fisher critica questa narrazione, sottolineando come trasformi questioni che dovrebbero essere affrontate collettivamente in battaglie personali, lasciando gli individui soli a confrontarsi con i propri problemi e isolandoli ulteriormente.
Nell’ottica della privatizzazione possiamo pensare anche alla diagnosi di autismo. Sebbene questa diagnosi rappresenti una chiave interpretativa, un momento di comprensione di sé per molte persone (per me lo è stato e continua a esserlo, ad esempio), rischia di trasformarsi in un’etichetta che confina l’autismo a una questione privata. Questa etichettatura solleva implicitamente la società dalla responsabilità dell’esclusione che provoca, ignorando il suo ruolo attivo nel creare barriere e nel disabilitare le differenze. L’autismo, in questo contesto, diventa un ulteriore esempio di come il sistema marginalizzi coloro che non si conformano agli standard di normalità, spingendo verso una normalizzazione che ignora il valore intrinseco della diversità umana.
È in questa privatizzazione dell’esclusione e delle difficoltà quotidiane che si cela la trappola più insidiosa. Una volta etichettati e messi da parte come difettosi, la lotta per la parità di opportunità e per un mondo più accessibile si trasforma in un problema personale, privato, in un difetto da riparare, lasciando intatte le barriere strutturali che disabilitano le persone autistiche. La narrazione egemone descrive come nostro dovere individuale conformarci e adattarci, una costruzione che serve unicamente a perpetuare lo status quo. Espressione dell’egemonia culturale, nel senso gramsciano del termine, di una classe che esercita il potere sulle altre anche limitando la loro capacità di autorappresentarsi, di autodeterminarsi e provare a incidere quindi sul proprio futuro.
In una società ossessionata dalla produttività e dalla competizione a ogni costo, la consapevolezza della propria neurodivergenza può trasformarsi così in un’arma a doppio taglio. Ci viene incessantemente ripetuto che riconoscere e accogliere la nostra diversità rappresenta il passaggio obbligato verso l’inclusione. Eppure, questo processo si rivela fallace senza un’analisi critica delle strutture sociali ed economiche che innalzano le barriere contro la diversità, trasformando la convivenza in “normalizzazione”, e considerandola inoltre un obbligo personale. In questo modo, l’accettazione di sé diventa non una liberazione ma un ulteriore strumento di conformità: ci viene implicitamente affidato il compito di adattarci e integrarci secondo standard che non abbiamo scelto, trascurando il ruolo disabilitante delle dinamiche sociali dominanti.
La vera consapevolezza sull’autismo richiede un cambio di prospettiva. Basta con questa celebrazione astratta della diversità; dobbiamo interrogarci sulle dinamiche di potere che definiscono la normalità e la diversità, che stabiliscono cosa significa essere “divergenti”. Dobbiamo rifiutare la narrazione che relega l’autismo a una questione privata, e lottare per una società che riconosca ogni individuo non per la sua capacità di adattarsi a un ideale illusorio di normalità, ma per il suo intrinseco diritto di esistere.
In questo 2 aprile, facciamo della consapevolezza un punto di partenza per una riflessione collettiva. Mettiamo in discussione le narrazioni che limitano, privatizzano e marginalizzano. L’autismo, come ogni esperienza umana, va compreso nella sua complessità e totalità, e noi come società dobbiamo affrontare l’abilismo come un problema strutturale, e considerare le barriere una questione comunitaria che, per essere risolta, necessita dell’impegno di ogni persona, necessita della consapevolezza di tutte e di tutti ma inserita in un discorso collettivo, non individualistico né individualizzato.