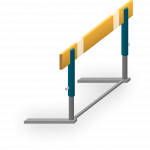Etichette, categorie, gabbie anguste in cui vengono infilate le persone e giudicate a seconda delle loro caratteristiche, e in base a esse private di una equa partecipazione alla vita sociale.
Etichette, categorie nelle quali ci rinchiudono perché dare un nome a ciò che è statisticamente meno frequente, a ciò che appare fuori dall’ordinario, può aiutare a comprendere ma serve anche a tenere d’occhio, a poter controllare meglio.
Etichette, categorie che ci vengono imposte dall’alto senza aver mai domandato se è così che vogliamo definirci; etichette che però ci rendono visibili, rendono manifesta la nostra esistenza. Le nostre vite nominate come categorie speciali non passano più inosservate, e allora le etichette che ci hanno cucito addosso si trasformano in identità. Ci ritroviamo così tra persone con etichette simili, cercandoci confrontiamo le nostre esperienze e scopriamo di non essere sole. Ci uniamo e le nostre voci cominciano a infastidire quella parte di mondo che non ha bisogno di etichette, il mondo ordinario, che non è definito da categorie particolari perché rientra o si avvicina abbastanza a una norma fittizia che stabilisce i confini tra essere dentro o fuori, tra godere di uguali diritti o dover lottare per strappare quelli che a loro appaiono scontati.
Ogni persona può avere più di un’etichetta, può averne tante quante sono le caratteristiche di sé che il mondo decide essere fuori norma, troppo lontane da quei parametri, dalla pancia di una curva gaussiana divenuta ormai simbolo di appartenenza alla maggioranza o di esclusione. Le etichette non le scegli, ti arrivano quando il mondo si accorge che qualcosa in te non coincide con le aspettative, che non corrispondi a un modello ideale di essere umano creato a tavolino da un pensiero riduzionista e determinista, frutto di un intramontabile darwinismo sociale che cerca difetti da correggere, devianze da ricondurre al modello normativo.
Le etichette non le scegli ma quando te le ritrovi stampate addosso dall’esterno, cominci a usarle. A volte il semplice atto di nominarle infastidisce il mondo perché gli ricorda che esisti; perturba l’ordine delle cose, quell’ordine che non prevede la tua esistenza e proprio per questo decide di etichettarti: fuori norma. E quando decidi di usarle come identità, quelle etichette che non hai mai chiesto, quando le sbatti in faccia proprio a chi te le ha appiccicate all’anima, allora loro non le vogliono più. Basta, gridano, siamo tutte persone, tutte uguali, che è ‘sta cosa di dover nominare tutto? dicono. Perché le etichette possono usarle solo loro su di te, su chi non è conforme alla loro idea distorta, semplicistica e infantile di realtà. Una realtà di plastica dove tutto ciò che non rientra nella superficiale capacità di comprensione dettata dalla norma viene escluso, etichettato e messo da parte. E infatti il marchio, secondo il mondo, a questo dovrebbe servire, a mettere in guardia dalla tua presenza, dalla tua esistenza. Non prevedevano, nella stoltezza di un sistema superficiale e insostenibile, che la cosa sarebbe sfuggita loro di mano, che le etichette avrebbero assunto un valore identitario, aggregante, e che queste identità dal margine avrebbero addirittura utilizzato la parola ORGOGLIO per definire la propria esistenza.
Ma al mondo, questa presa di coscienza non piace affatto. Orgoglio? Cos’hai da essere orgogliosa di essere donna? Che orgoglio c’è nell’essere gay o lesbica o trans o fluida o nera o disabile? Orgoglio di che? ma se vi abbiamo affibbiato quelle etichette per sottolineare la vostra inferiorità, per tenervi fuori dal nostro mondo!
Eccolo, il problema delle etichette, che se da una parte non possono fare a meno di affibbiarle a qualsiasi caratteristica ritengano fuori norma, dall’altra non sanno gestire le identità che da esse prendono forma. E allora provano a silenziarle, a renderle invisibili togliendo loro la parola, decidendo dall’esterno quale dev’essere la loro narrazione nel mondo, perché lo sanno bene che se di te non si parla, se nessuno sa chi sei, allora non esisti.
A cosa serve sottolineare che quella discriminazione è omofoba? domandano coloro che non hanno mai subito discriminazione per essere chi sono, perché soddisfano le aspettative dettate dalla norma. Le discriminazioni sono tutte sbagliate, non serve fare distinzioni, dicono. Perché specificare che quella violenza è di genere? la violenza è tutta sbagliata, affermano. Insomma, perché stare a sottolineare le differenze tra le persone? siamo tutte uguali, dicono sempre loro che, ancora prima che tu nasca, ti affibbiano un colore, rosa o azzurro, e con esso una strada fatta di aspettative e obblighi.
E invece quelle differenze vanno sottolineate, vanno urlate, mostrate al mondo senza vergogna, con orgoglio. Perché quel ragazzo non l’avrebbero picchiato se non fosse uscito da un “locale gay” tenendo per mano un altro ragazzo; perché se fosse uscito da uno dei tanti locali senza etichette, quelli che chiamiamo solo “locali” e se per mano avesse tenuto una ragazza, probabilmente non l’avrebbero riempito di botte urlandogli addosso proprio quell’etichetta, declinandola in tutte le forme possibili, brandendola come una mazza. E lo stesso vale per ogni forma di discriminazione, perché la discriminazione è necessariamente la conseguenza di un’etichetta.
Per questo la violenza non è tutta uguale, per quanto sia sempre tutta da condannare, perché a volte esistono aggravanti generate proprio dall’etichetta che ti è stata consegnata. Perché non siamo tutte, tutti e tuttə uguali, siamo differenti, e le differenze o le accetti come un fatto naturale e cerchi di conviverci, di comprenderle e di lasciare che ti arricchiscano anche mettendo in discussione le tue certezze, oppure le combatti, le etichetti, le schiacci e le nascondi, e quando saltano fuori urlando per chiedere giustizia minimizzi, cerchi di togliere loro visibilità, voce.
Il problema però non è necessariamente nell’etichetta in sé ma nel valore che le viene attribuito, è nello squilibrio di potere che genera tra chi viene marchiata perché diversa e quindi tenuta ai margini o fuori dai margini della società, e chi crede che il proprio modo di essere, di agire e pensare sia l’unico possibile, l’unico giusto, e quindi non necessita di un’etichetta, non ha bisogno di essere nominato.
Forse, come suggerisce il sociologo Eviatar Zerubavel (Zerubavel, E., 2019, Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà, Meltemi), dovremmo cominciare a “esplicitare l’implicito”, a nominare anche la normalità, a specificare ogni volta che a picchiare quella “persona gay” è stato un gruppo di “persone eterosessuali”, dovremmo sottolineare tutte le volte in cui il ladro, il truffatore o lo stupratore era “italiano” e non solo quando era “extracomunitario”, oppure dovremmo cominciare a scrivere articoli sui giornali per celebrare il “ragazzo neurotipico laureato con 110 e lode” e non solo quando a laurearsi è un “ragazzo autistico”. Dovremmo etichettare tutto e cominciare a chiamare col loro nome anche quelle categorie che diamo per scontate, quelle “nella norma”, per far comprendere loro che quella norma è solo una delle infinite possibilità di esprimersi che la natura umana conosce. E allora è possibile che quell’alone di inferiorità e negatività che accompagna tante etichette e identità, quello stigma che genera esclusione sociale e dolore si affievolisca fino a sparire, e ci rendiamo finalmente conto che la frequenza con cui certe caratteristiche si presentano nella popolazione è un dato descrittivo, non un’attribuzione di valore, e di certo non un motivo di esclusione.