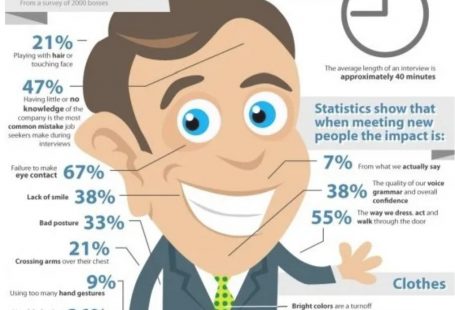Una delle conseguenze di vivere, studiare e, ovviamente, lavorare in una cultura che premia e considera vincenti gli individui le cui caratteristiche si riscontrano con maggiore frequenza nella popolazione è quella di interiorizzare il senso di inferiorità, di inettitudine e a volte di disprezzo che la società, anche attraverso l’uso di un linguaggio che distorce l’immagine delle persone considerate differenti dalla media, trasmette attraverso una narrazione normocentrica.
Il sessismo, l’omolesbobitransfobia, il razzismo ma anche l’abilismo (la discriminazione sulla base del presunto valore negativo che assumono determinate caratteristiche psicofisiche e sensoriali) sono forme di discriminazione che, quando interiorizzate, vengono attuate anche dalla persona nei confronti della propria categoria di appartenenza o, addirittura, verso sé stessa.
Crescere in una cultura nella quale l’omosessualità viene descritta come un vizio, oppure come frivola, come un pericoloso stile di vita o, cosa fin troppo diffusa, come se fosse una scelta individuale (di cui essere responsabili), può portare alcune persone a rifiutare o a vedere la propria condizione come indesiderabile perché influenzate dalla rappresentazione delle proprie caratteristiche basata su degli stereotipi. […]
Quando si accettano le opinioni e i pregiudizi discriminatori che circolano nella cultura dominante si finisce per interiorizzarli, si assume in pratica l’atteggiamento discriminatorio della propria cultura in modo generico e lo si applica anche a sé stesse e ai membri del proprio gruppo. Questo può accadere a chiunque, esistono infatti persone disabili che hanno interiorizzato l’abilismo che dilaga nella nostra società pensando a sé stesse e alle altre appartenenti alla categoria della disabilità come incapaci, inferiori. Capita alle persone autistiche, che sono convinte di dover cambiare, di dover usare violenza verso sé stesse per comportarsi in modo “normale” e assomigliare ai modelli di socialità e di funzionamento imposti dalla società neurotipica. Capita alla persona nera che interiorizza il razzismo di cui la nostra cultura è intrisa, spesso inconsapevolmente, vedendo sé stessa come inferiore, meno meritevole di successo nello studio o nel lavoro.
Un esempio di quanto l’interiorizzazione degli atteggiamenti discriminatori messi in atto dalla società normocentrica, in questo caso in relazione al fenomeno del razzismo, è quello del doll test [1],un esperimento progettato dagli psicologi Kenneth e Mamie Clark negli anni Quaranta per osservare gli effetti che la segregazione razziale aveva sui bambini e le bambine afroamericane e in che modo sviluppassero il senso del sé in relazione alla percezione della propria appartenenza etnica.
L’esperimento fu condotto su un campione di 253 bambine e bambini di età compresa tra i tre e i sette anni, a ciascuno dei quali vennero mostrate quattro bambole identiche tranne che per un elemento: due delle bambole avevano la pelle scura e i capelli neri, le altre due invece erano di pelle chiara e capelli biondi. Ai bambini e alle bambine venne, nell’ordine, chiesto di indicare la bambola con cui avrebbero preferito giocare, quella che a loro piaceva di più, e poi quale delle due fosse la bambola buona e quale la bambola cattiva. Venne loro chiesto di indicare quale fosse la bambola dalla pelle chiara e quale quella dalla pelle scura e, infine, quale bambola assomigliasse loro.
Dopo aver letto i risultati dello studio sono rimasto piuttosto turbato perché non immaginavo quanto potente e pervasiva potesse essere l’interiorizzazione degli stereotipi razziali, e soprattutto quanto precocemente fossero presenti in modo incosciente nella mente dei bambini. I risultati dei doll studies erano chiari: la maggioranza dei bambini neri aveva una preferenza per le bambole bianche. Quando è stato chiesto ai bambini quale bambola preferissero e quale fosse “buona” e “bella”, la maggior parte ha attribuito caratteristiche positive alle bambole bianche. Le caratteristiche negative sono state attribuite principalmente alle bambole nere. In termini di identificazione razziale, il 90 per cento dei bambini e delle bambine è stato in grado di identificare con precisione le bambole come bianche o nere; tuttavia, il 33-50 per cento dei bambini neri si è identificato con la bambola bianca. Kenneth Clark ricorda alcuni bambini così emotivamente sconvolti durante l’esperimento che si precipitarono fuori dalla stanza dopo essersi identificati con la bambola che gli piaceva di meno e descritta come cattiva[2].
Guardate l’esperimento su YouTube[3], osservate l’espressione di quei bambini e quelle bambine a mano a mano che le domande dell’intervistatore avanzano; notate come il sorriso svanisce quando si rendono conto di essere loro la bambola nera, quella brutta, quella cattiva. Forse vale realmente la pena domandarci quanto sia importante cominciare a cambiare le cose partendo dal modo in cui ci raccontiamo la realtà e da come impediamo a chi giudichiamo differente di raccontare la propria.
Fornire una descrizione alternativa del mondo in cui la diversità viene accolta con caritatevole magnanimità forse ci farà sentire protetti, ma ci allontana dalla verità creando una società parallela in cui la vita vera non entra se non si adegua alle norme severe e restrittive di questa realtà. Raccontare un mondo in cui la perfezione, l’incarnazione dei valori positivi è rappresentata da quella norma artificiale in cui, a voler essere precisi, non rientrerebbe nessuno ma a cui in molti cercano disperatamente di avvicinarsi il più possibile, non mette però né noi né le nostre figlie e i nostri figli al riparo dal pericolo. Anzi, ci espone tutti al rischio di accartocciarci su noi stessi, di diventare sempre più infelici in questa corsa verso una impossibile e irreale perfezione.
Abbiamo creato un mondo in cui attribuiamo un valore alle caratteristiche delle persone, a dei tratti che la natura distribuisce aleatoriamente tra noi e che le circostanze contribuiscono a rendere ancora più impossibile prevedere. E questa arbitraria assegnazione di un valore legato a un’idea performativa di produttività, di “utilità” di un individuo che vede sé stesso sempre più solo e privo dell’appoggio di una società ormai disintegrata e competitiva, ci porta a escludere dalla nostra visuale chiunque rischi di inquinarla con i suoi difetti.
Quelle persone che facciamo scomparire non nominandole o che raccontiamo come inferiori, difettose, bisognose della nostra elemosina perché da sole non potrebbero farcela, siamo noi, sono i nostri fratelli e sorelle, i nostri figli, le figlie, sono quei “difetti” che cerchiamo di nascondere, quelle parti di noi stesse che ci sforziamo disperatamente di modificare per assomigliare a un ideale di normalità disumano. Interiorizziamo gli stereotipi negativi e lo stigma verso quelle caratteristiche che esprimono una universale diversità che ci accomuna. […].
Tratto dal mio ultimo libro: Di pari passo. Il lavoro oltre l’idea di inclusione. LUISS University Press.
DISPONIBILE QUI
NOTE
[1] K.B. Clark, M.P. Clark, “Racial identification and preference in Negro children”, in T.M. Newcomb, E.L. Hartley (a cura di), Readings in social psychology, Holt, Rinehart & Winstonm, New York 1947, pp. 602-611.
[2] S. Howard (Ph.D.), K. Kennedy (M.S.), “The ‘Doll Studies’, Kenneth B. Clark and Mamie P. Clark, 1947”. Marquette University
[3] Per un esempio realizzato in Italia: www.youtube.com/watch?v=QRZPw-9sJtQ&t=140s. Per una versione in inglese: www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM.