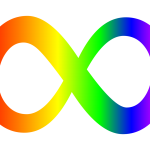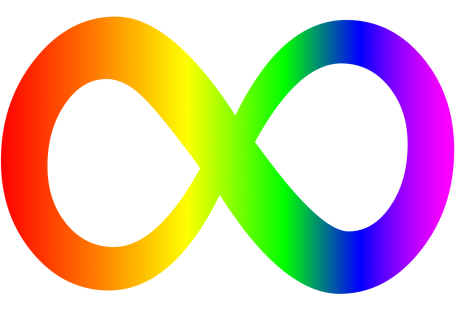Venerdì sera ho partecipato a un webinar in cui si è parlato del Progetto di vita, nello specifico ieri ne abbiamo discusso – insieme anche a due genitori – in relazione alle persone autistiche.
Il progetto di vita è uno strumento istituito dalla legge che prevede la creazione di percorsi integrali che, in teoria, dovrebbero mirare a coinvolgere ogni aspetto della vita delle persone disabili, incluse ovviamente tutte quelle persone nello spettro autistico le cui caratteristiche ne limitano l’autonomia sotto vari aspetti.
Quello che mi ha maggiormente colpito della chiacchierata informale su questo argomento è l’incapacità della nostra società di gestire l’incredibile varietà di caratteristiche espresse dagli individui che la compongono. In particolare è evidente un’asimmetria relazionale tra le persone appartenenti a quella parte di popolazione che viene definita “abile” e coloro che invece, in base all’ideale performativo e biomedico che pervade il nostro pensiero e che si concentra sulla presunta mancanza o sulla perdita di alcune funzioni, sono marchiate come non abili in determinate aree della propria esistenza.
Il progetto di vita è un’idea encomiabile che dovrebbe rendere possibile la creazione di un percorso che accompagni la persona durante tutta la sua esistenza, fornendole gli strumenti per crescere e guadagnare autonomia, per raggiungere obiettivi in linea con le caratteristiche individuali e soddisfare le proprie aspirazioni; per autodeterminarsi e, laddove non fosse possibile, farlo grazie all’aiuto delle figure di riferimento che meglio possono aiutarla a esprimere queste aspirazioni, a fare emergere le sue capacità.
Purtroppo, però, Pierluigi e Cristiana, i due genitori presenti alla discussione, ci hanno raccontato una storia diversa. Il progetto di vita, almeno nella maggior parte dei casi, invece di essere uno spazio aperto e in divenire che muta assieme alla persona – perché nessun individuo, anche disabile, resta immobile e identico a se stesso per tutta la vita – diventa un percorso dai confini stretti e immutabili, basato essenzialmente su quello che la persona non può fare invece che sulle sue possibilità.
Il problema, ancora una volta, è la visione monocroma che accompagna la diversità nella nostra società, soprattutto quando questa diversità si esprime attraverso corpi, menti e sensi non conformi a un ideale legato all’idea di produttività, quando la diversità rende la persona non allineata a quegli ideali di autonomia che nascondono in modo nemmeno troppo velato un imperativo di sviluppo personale finalizzato a una produttività e a una capacità di consumo sempre più standardizzate.
La monocromia di questa visione si manifesta sotto forma di discorso prettamente medico riabilitativo, discorso che però, quando si tratta di creare un progetto di vita globale e in divenire, mostra tutti i propri limiti proprio perché incapace di vedere la persona per ciò che è, ossia un individuo con determinate caratteristiche, con dei desideri e delle necessità proprie e il diritto alla realizzazione personale in base proprio a quelle caratteristiche uniche che la contraddistinguono. Un limite dell’approccio esclusivamente medico alla persona è che la cristallizza nella descrizione diagnostica. Crea in questo modo una serie di modelli che devono necessariamente andare bene per chiunque venga catalogato in base a una specifica etichetta.
Il risultato, che trovo personalmente avvilente, è che metaforicamente si costringono le persone disabili a indossare degli abiti preconfezionati dei quali non possono scegliere né colore, né disegno e nemmeno il tessuto, e per i quali sono disponibili solo un paio di taglie: piccola e grande. Mentre invece il resto della popolazione ha la possibilità di scegliere tra un’infinità di abiti, di stili e tessuti, e in moltissimi casi può addirittura farsi tagliare un vestito su misura in base ai propri desideri e alle proprie caratteristiche fisiche.
È un po’ come dire: se sei differente dalla maggioranza, allora devi accontentarti del percorso standard riservato alle persone come te. Per gli individui che invece rientrano nei canoni di una fittizia normalità, esiste invece la possibilità, entro certi limiti, di scegliere.
Non riusciamo a uscire da questo recinto che ci misura e ci giudica solo in base alla possibilità dei nostri corpi e delle nostre menti di funzionare con l’unico fine di essere elementi produttivi (secondo determinati standard, ovviamente) di una società ossessionata dalla performance e dall’omologazione funzionale.
L’approccio della nostra società alla diversità, soprattutto alla disabilità, si rivela così discriminatorio anche nel processo di inclusione, come sostengo ormai da tempo. E questa discriminazione si manifesta nell’incapacità di vedere l’altro come pari, si mostra nella negazione ad alcuni individui di diritti fondamentali, della possibilità di godere di una vita soddisfacente e ricca a prescindere dalle caratteristiche dei loro corpi e delle loro menti. Come se esistesse un’unica modalità di soddisfazione e di arricchimento personale, quella prodotta da corpi e menti standard, abili, nella media o sopra di essa.
L’abilismo che abbiamo interiorizzato ormai inconsapevolmente rende vani anche progetti che sulla carta sarebbero validi e auspicabili, ma che all’atto pratico vengono sabotati dall’aver delegato a una visione basata sull’idea di deficit la gestione delle differenze, immaginandole come entità aliene al tutto, come problemi da dover risolvere seguendo un pensiero riduzionista e meccanicistico che non può, per forza di cose, cogliere la complessità della vita in tutte le sue sfaccettature.
È urgente ripensare il nostro rapporto con l’altro, è fondamentale stabilire uno scambio reciproco e paritario tra esseri umani che riesca finalmente a liberarsi del paternalismo e del pietismo di una relazione assistenziale a senso unico per dipanarsi in una rete complessa di rapporti pluridirezionali, equi, solidali, il cui scopo sia di garantire a ciascuna persona il diritto di esistere e di crescere assecondando il proprio essere. È necessario stabilire una relazione di convivenza basata sul rispetto della complessità dell’esistenza umana, per garantire a chiunque un progetto di vita dignitoso e soddisfacente.