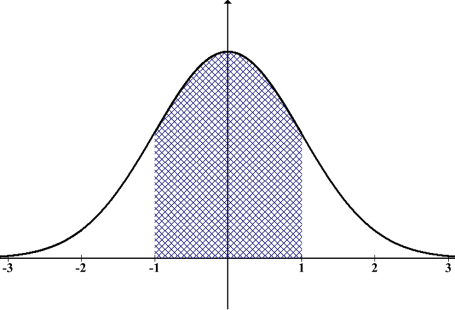Damian Milton, ricercatore universitario autistico, ha proposto la teoria della “doppia empatia”[1] per l’autismo. Questa teoria, che di fatto rade al suolo in un colpo solo tutte le speculazioni abiliste sui vari deficit nella teoria della mente, nell’empatia e nella coerenza centrale, ci spiega una cosa elementare eppure fino a oggi invisibile agli occhi delle ricercatrici neurotipiche: il problema risiede nel punto di vista.
Già, perché il punto di vista negli studi e nelle politiche sull’autismo è stato sempre e solo quello delle persone neurotipiche e l’empatia, caratteristica oggi pompata fino quasi a esplodere da una cultura dell’auto-aiuto dopata da troppa psicologia positiva, nell’autismo è stata presa di mira, crocifissa ed esposta al pubblico ludibrio come esempio lampante di quei “deficit nell’area sociale” di cui tanti specialisti amano parlare.
Damian Milton sostiene che il problema non stia nei presunti deficit dell’autismo ma risieda nell’interazione tra persone autistiche e non autistiche, tra due funzionamenti neurologici differenti che non riescono a comprendersi reciprocamente proprio perché, possedendo ciascuna categoria un sistema nervoso organizzato in modo differente, reagiscono agli stimoli in maniera diversa, rapportandosi al mondo diversamente. Si tratta allora di mettere in discussione non l’empatia, ma le convenzioni sociali che ciascun gruppo attua come conseguenza. [2]
Il problema non sarebbe quindi solo nostro in quanto autistiche, ma di comunicazione tra autistiche e neurotipiche: non ci capiamo perché parliamo due lingue differenti.
A questo punto possiamo estendere il discorso a tutte le aree del funzionamento umano e parlare non solo di “doppia empatia”, ma di “doppio funzionamento”. Se ci pensiamo bene il discorso continua a essere abbastanza ovvio: un sistema nervoso organizzato diversamente rende la percezione degli stimoli esterni e di quelli interni all’organismo differente. Già abbiamo così un primo elemento di diversità: quello che tu percepisci come normale per me potrebbe risultare insopportabile, oppure uno stimolo per me piacevole potrebbe per te risultare doloroso.
Ma la cosa prosegue perché un diverso sistema nervoso non solo percepisce, ma elabora gli stimoli diversamente e altrettanto diversamente reagisce a essi. Questo significa che comportamenti apparentemente anomali, strani, incomprensibili degli autistici hanno un loro motivo di esistere in quanto reazioni a un ambiente percepito ed elaborato diversamente non per capriccio, ma a causa di differenze nel sistema nervoso che oggi appaiono sempre più chiare alla scienza. [3,4]
Se seguiamo la teoria di Milton e l’applichiamo al funzionamento della persona nella sua totalità, spostando il punto di vista al di fuori della visione neurotipica come se ci fosse una terza persona che osserva, allora ci accorgiamo del trucco: lo stesso discorso vale per il comportamento neurotipico. Che esso sia considerato “normale” è una questione di numeri, di maggioranza che stabilisce cosa è normale e cosa non lo è escludendo automaticamente chiunque si allontani da questo concetto.
Bene, ma tutto questo cosa c’entra con il mondo del lavoro? C’entra eccome, c’entra perché fino a oggi la quasi totalità degli interventi a favore del cosiddetto inserimento lavorativo degli autistici e delle autistiche hanno affrontato la questione guardandola da un solo punto di vista, quello neurotipico. L’autistica è strana, si sono detti i neurotipici, fa cose strane che a noi non piacciono e che non riusciamo a capire, quindi dev’essere sbagliata. E se è sbagliata dev’essere riparata, addestrata, “educata” a essere introdotta in questo mondo competitivo pervaso da una necessità di conformismo che tende a schiacciare ogni differenza.
Quindi per inserire (parola che fa il paio con includere, atto che la diversità deve subire passivamente) l’autistico in azienda, lo si deve istruire con un corso o un training. Cosa sulla quale io sono d’accordo, anzi, credo sia indispensabile fornire a una persona autistica quelle conoscenze sul funzionamento neurotipico, soprattutto sul lavoro.
Però, e c’è un però enorme, a due condizioni. La prima è che questi training abbiano lo stesso scopo di quelli che vengono fatti a qualsiasi dipendente appena assunta: fornire strumenti per comprendere un ambiente nuovo e per poter svolgere i compiti richiesti al meglio. E facciamo attenzione perché questo è completamente diverso da ciò che quasi sempre accade oggi, che è invece il voler modificare dei comportamenti naturali per una persona in modo da farla apparire meno diversa, meno strana, in un ambiente in cui la diversità ha vita breve quando non si sottomette a certi requisiti.
La seconda condizione che propongo viene dall’idea che, trattandosi di due funzionamenti sociali differenti prodotti da differenti tipologie di sistemi nervosi, una categoria non può in alcun modo essere considerata migliore dell’altra. Se si parte dal presupposto che il comportamento neurotipico sia quello giusto, allora si sta chiaramente discriminando chiunque abbia un comportamento differente, non solo le persone autistiche. Se pensiamo che le persone neuroatipiche o disabili siano inferiori, che abbiano qualcosa di difettoso, siamo profondamente abiliste, e questo pensiero abilista genererà sempre e solo soluzioni abiliste che imporranno la rinuncia al proprio funzionamento naturale solo a una delle due parti.
Io invece non sono abilista, e non mi sognerei mai di dire che noi autistici e autistiche siamo migliori delle persone neurotipiche, non le discriminerei mai per quei comportamenti così peculiari o per la loro socialità così sviluppata. E non essendo abilista, credo che se alle autistiche è richiesto un training per comprendere il funzionamento del mondo neurotipico sul lavoro, allora alle aziende (management e dipendenti) andrebbe richiesto di partecipare a dei training per comprendere il mondo neuroatipico.
Finché non si abbatterà questa idea del noi contro loro, dell’io sono meglio di te, del tu devi diventare simile a me, non si andrà mai da nessuna parte. Se si spera di forzare delle modifiche comportamentali eticamente discutibili nelle persone autistiche e poi lanciarle in un mondo che non tiene conto di quelle differenze del sistema nervoso di cui parlavo prima, il risultato sarà un burnout col botto.
Per far comprendere meglio la cosa propongo in breve esercizio. Tornate con la memoria ai mesi di marzo e aprile: improvvisamente l’umanità è stata costretta ad abbandonare la propria socialità, le è stato proibito il contatto fisico, poter vedere amici e parenti, una birra insieme il sabato sera. Da un giorno all’altro siamo stati costretti in casa tutto il giorno, abbiamo cominciato a lavorare da casa, a condividere spazi che giorno dopo giorno diventavano sempre più angusti con familiari o coinquilini; siamo state obbligate a cambiare il nostro comportamento, a reprimere le nostre necessità. Comprensibilmente la cosa ha generato malessere, un’impennata nelle richieste di aiuto per problemi psicologici e neurologici come depressione e disturbo da stress postraumatico, un aumento dei conflitti familiari.
Questo per una situazione che, ci auguriamo, è transitoria e di durata limitata. Ora immaginate che, per una persona autistica, questa è la quotidianità con o senza coronavirus fin dall’infanzia. Forse quindi è davvero il caso di pensare che, se da un lato noi autistiche e autistici dobbiamo sicuramente comprendere il funzionamento neurotipico sul lavoro, dall’altro il mondo del lavoro deve comprendere il nostro funzionamento, anche da un punto di vista dell’adattamento degli spazi fisici.
Parliamoci chiaro: nessun intervento di inserimento lavorativo funzionerà mai né sarà mai eticamente accettabile fino a che non prevederà uno sforzo di comprensione equo da parte di entrambi i gruppi. E ripeto, comprensione, non modifica forzata del proprio funzionamento. Ciascun gruppo deve necessariamente apprendere il linguaggio dell’altro perché solo conoscendo i punti deboli e quelli di forza di ciascuna parte possiamo mettere in atto strategie che favoriscano la convivenza delle differenze.
Se io sono più bravo a catalogare e ordinare e tu sei più fluida nell’interazione con altri dipartimenti o con i clienti, non è più pratico pensare a una collaborazione in cui ciascuna possa esprimere il proprio talento personale? Perché forzare me verso un funzionamento sociale che non mi appartiene e costringere te a diventare maniaca dell’ordine e una catalogatrice provetta quando potremmo completarci a vicenda? Perché non cercare punti di incontro tra i due stili comunicativi, cognitivi ed emotivi, invece di volerne modificare sempre e solo uno per farlo assomigliare malamente all’altro che è considerato normale?
NOTE
[1] Milton, D. E. M., Heasman, B., & Sheppard, E. (2020). Double Empathy. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders, 1–9. doi:10.1007/978-1-4614-6435-8_102273-2
[2] Fletcher-Watson, S., & Bird, G. (2020). Autism and empathy: What are the real links? Autism, 24(1), 3–6. https://doi.org/10.1177/1362361319883506
[3] Hyde, K. L., Samson, F., Evans, A. C., & Mottron, L. (2009). Neuroanatomical differences in brain areas implicated in perceptual and other core features of autism revealed by cortical thickness analysis and voxel-based morphometry. Human Brain Mapping, NA. https://doi.org/10.1002/hbm.20887
[4] McAlonan, G. M. (2004). Mapping the brain in autism. A voxel-based MRI study of volumetric differences and intercorrelations in autism. Brain, 128(2), 268–276. https://doi.org/10.1093/brain/awh332