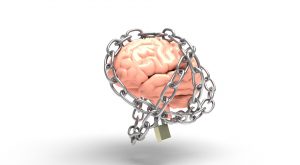
La diagnosi di una condizione del neurosviluppo, come nel caso dell’autismo, è una soluzione imperfetta resa necessaria da una società altrettanto imperfetta e incapace di gestire adeguatamente le differenze tra gli individui che la compongono. Personalmente, credo che una società matura non dovrebbe guardare a queste condizioni esclusivamente dal punto di vista medico, come invece avviene oggi nella maggior parte dei casi.
Fino a che non si riuscirà ad andare oltre la diagnosi clinica ci troveremo con gruppi di persone – in questo caso gli autistici – che, pur di non essere esclusi a causa di quelle differenze incompatibili con la normalità imposta come modello unico, preferiranno ricevere questa etichetta diagnostica diventando così una sorta di specie protetta (e nemmeno troppo protetta), e finendo per vivere una discriminazione, anche se differente, che allo stesso tempo compatisce ed esclude, ma se non altro può fornire un minimo di supporto. E ho detto un minimo.
Quando mi riferisco all’importanza della diagnosi, quindi, lo faccio consapevole di quanto essa sia una soluzione imperfetta, una toppa ideologica che copre malamente quello squarcio che la società non riesce a ricucire da sé, ma che almeno può spostare l’autistico da una condizione di biasimo sociale per l’impossibilità di attenersi ai modelli imposti dalla cultura dominante, a una situazione in cui tale impossibilità viene se non altro “giustificata” clinicamente.
Questo passaggio potrebbe apparire insignificante, se non fosse che è in grado di migliorare a volte di molto la qualità della vita di un autistico, fermo restando che quella nuova etichetta medica porta con sé tutta un’altra serie di limitazioni e pregiudizi, e che non potrà esistere una reale inclusione fino a che le etichette non lasceranno il posto all’inclusione della persona nella sua complessità.
La domanda se la diagnosi sia utile o consigliabile è una delle più frequenti che ricevo, e vorrei spiegare in modo molto semplice perché credo che tale strumento imperfetto possa, nonostante tutto, essere utile in una società immatura nei confronti della diversità, ovviamente a patto che si lavori al superamento di tale strumento.
Voglio allora tornare indietro di qualche anno (ok, più di qualche anno) e osservare la mia vita da due punti di vista differenti: il mio e quello dei miei familiari.
Ho già raccontato più volte, tanto in vari articoli che nel libro, quanto l’adolescenza sia stato probabilmente il periodo più buio e complicato della mia vita. Le mie giornate erano delle arrampicate su pareti verticali a mani nude, le richieste sociali aumentavano terribilmente, la società imponeva che cominciassi a pensare seriamente al futuro, a fare delle scelte che avrebbero avuto un impatto sulla vita lavorativa quando ancora non sapevo chi realmente fossi, cosa desiderassi. Intorno a me i coetanei cominciavano a sperimentare l’amore, le relazioni, andavano incontro ai normali momenti di crisi sentimentale e familiare; si costruivano il loro posto nella società coi mezzi che la società gli metteva a disposizione, dei mezzi che però funzionano esclusivamente se anche tu funzioni nel modo previsto.
Io non avevo alcuna certezza se non quella che vivevo per la musica, la scrittura e lo studio della psicologia. Ero completamente assorbito dalla musica e dalla psicologia e trascorrevo notti insonni a scrivere racconti su racconti che poi non leggeva mai nessuno. Diciamo che facevo tutto tranne che studiare per la scuola, ma per me dedicarmi completamente a quegli argomenti era una necessità, non una scelta; da quei tre interessi dipendeva la mia esistenza, quel minimo di serenità e stabilità e piacere che potevo sperare di ottenere nell’arco di una giornata.
E poi c’erano l’aspetto sensoriale e quello sociale che rimanevano per me un mistero. Ammiravo i miei coetanei, quei ragazzi che per periodi di tempo piuttosto brevi riuscivo a frequentare, invidiavo la loro capacità di sostenere conversazioni in gruppo senza arrivare poi a casa col cervello liquefatto, il loro piacere nell’andare in luoghi affollati e rumorosissimi, posti che mi costringevo con la forza a frequentare nel tentativo disperato di sentirmi uno di loro.
L’ho detto tante volte e lo ripeto: a me procurava benessere starmene per conto mio a suonare, a scrivere o a leggere i miei libri di psicologia. E la passione per la psicologia, tra l’altro, credo sia nata proprio nella necessità di riuscire comprendere quei meccanismi che regolano l’interazione tra individui, e che per me erano in molti casi oscuri e incomprensibili. Stare da solo o con una, al massimo due o tre persone con cui però condividessi qualcosa (quasi sempre quel qualcosa era la musica) era anche un modo per non saturare i sensi evitando di sbroccare e sembrare completamente fuori di testa.
Ecco, fuori di testa è come devo essere apparso, soprattutto da un certo punto in poi, a chi con me condivideva quel luogo chiamato casa e nel quale mi ero ritagliato e organizzato la mia tana piena di libri, strumenti musicali (a un certo punto in camera mia c’erano un pianoforte acustico, uno elettronico, due clavicembali e un violino). Mio padre me lo disse apertamente quando io, altrettanto apertamente, dichiarai che avrei lasciato la scuola per studiare musica a quattordici anni: «Fabrizio, tu non stai bene» mi disse, «adesso prima risolviamo questo problema [con uno psichiatra] e poi [di questa follia della musica] ne parliamo quando starai meglio».
Che mi vedessero problematico, strano, anormale, era giustificato anche dal fatto che il famigerato psichiatra non mi diede un’etichetta di autismo perché, a quei tempi, l’Asperger ancora non esisteva come diagnosi, e per essere marchiato come autistico dovevi assomigliare più a Rain Man che a Shaun Murphy di Good Doctor. Il ragazzo è depresso, fu il verdetto, non sta bene, ha problemi relazionali e affettivi, annientiamolo con un po’ di psicofarmaci così almeno la smette di urlare come un indemoniato per ogni sciocchezza, o di prendere a capocciate la parete quando sbrocca urlando che nessuno riesce a capirlo. Ed effettivamente ricordo che da quel momento, per mesi e mesi, non facevo altro che dormire.
Immagino che per i miei la situazione sarà stata davvero un incubo, e mi dispiace. Mamma era malata, il Lupus se la stava mangiando giorno dopo giorno, anno dopo anno, papà non ci capiva più nulla e non riusciva a darsi pace, e mia sorella si ritrovava con un padre (lui sì) depresso, una madre ammalata e bella schizzata pure lei, e un fratello che sicuramente la adorava, ma che proprio normale non era.
A peggiorare le cose poi c’era questa cosa che io non avevo amici, e i miei si sentivano in dovere di organizzarmi uscite disastrose coi figli dei loro amici nella speranza di “normalizzare” la mia situazione sociale. E poi la scuola, altra spina nel fianco. In alcune materie andavo benissimo ma in altre era un disastro. E non si capiva il perché: a volte dipendeva dall’insegnante che mi stava sulle balle e quindi non c’era verso, ma nella maggior parte dei casi era proprio la materia a non interessarmi minimamente. Ah, poi c’erano i compagni di classe, che non rendevano le cose più facili tra prese per il culo e bullismi vari.
Fatto sta che di scuole ne ho cambiate un bel po’ prima di “mettere la testa a posto”. E a farmi riflettere fu la mia insegnante di pianoforte che usò la musica, uno dei miei interessi speciali, come porta per entrare nel mio mondo e guadagnarsi la mia fiducia, mi prese con sé in conservatorio e mi convinse a portare a termine le scuole superiori e iscrivermi all’università. Dove il ricatto e la minaccia non erano riuscite, aveva funzionato l’entrare in sintonia coi miei interessi, il dimostrare apprezzamento per quello che facevo, farmi sentire importante, degno di interesse, accettato per quello che ero.
In quegli anni ho imparato a fingere, mi sono costretto a mimetizzarmi controllando con grande fatica ogni gesto, il tono e la cadenza della voce, l’andatura, il modo di usare lo sguardo. Ho studiato in modo scientifico come interpretare quei maledettissimi segnali non verbali che, intuitivamente, compresi già essere una delle tante cause dei miei problemi. E ci sono riuscito ma, come ho già spiegato, rimane tutt’ora un’abilità artificiale, qualcosa che devo ricordarmi di mettere in moto e che, nei momenti di stanchezza, smette di funzionare facendomi ripiombare nell’inconsapevolezza degli altri.
La diagnosi è imperfetta, è uno strumento che tende a medicalizzare una condizione di diversità e questo non è giusto né sempre necessario. Perché una cosa è affrontare da un punto di vista medico alcune caratteristiche per migliorare il proprio benessere, altra è prendere una persona nel suo insieme e dichiararla guasta, malata, bisognosa di cure che possano farla diventare più normale, più funzionale agli occhi della società. E chi se ne frega di cosa quella persona provi.
Eppure sono convinto che, se una diagnosi di autismo l’avessi ricevuta a quell’età e non da adulto, avrei avuto meno problemi. Mi sarei sentito meno difettoso, avrei probabilmente cominciato ad accettare le differenze con l’aiuto di uno psicologo e, sapendo da dove derivavano tante difficoltà, si sarebbe potuto lavorare a delle strategie per minimizzare l’impatto negativo dell’interazione col mondo sulla mia vita.
Avrei forse saputo che a farmi andare fuori di testa la maggior parte delle volte c’era un sovraccarico dei sensi e quindi, per evitare di star male io e far soffrire chi mi stava accanto, una soluzione sarebbe stata evitare di raggiungere il punto di non ritorno non ostacolando quei momenti di solitudine che dall’esterno invece apparivano come disfunzionali e venivano stigmatizzati.
A scuola forse determinati comportamenti non sarebbero apparsi come sfide o come disinteresse e (ipotizzando la presenza di insegnanti preparati) avrebbero potuto utilizzare modalità di apprendimento non standard, coinvolgendomi maggiormente in quelle materie per cui non nutrivo interesse invece di rimproverarmi e minacciarmi. I compagni non mi sarebbero probabilmente apparsi come dei modelli inarrivabili di perfezione e, chi lo sa, forse loro non avrebbero visto me come un nerd strano, antipatico e asociale.
E i miei avrebbero capito tante cose. Abbastanza da riuscire almeno a ridurre quel carico di dolore frutto del senso di responsabilità nei confronti dei miei fallimenti, di quegli incomprensibili comportamenti e delle continue e violente crisi. Forse avrebbero chiesto aiuto per riuscire a capire cosa mi accadeva dentro, invece di ostacolare sistematicamente qualsiasi tentativo di crescita personale solo perché si allontanava da quei maledetti modelli standardizzati imposti dall’esterno.
Forse ci saremmo voluti bene senza pagare quel prezzo altissimo che invece questo volerci bene ha significato: i sensi di colpa, le recriminazioni, i divieti e i litigi, le urla e a volte l’odio. E, soprattutto, la dolorosa incapacità di capire il perché.




