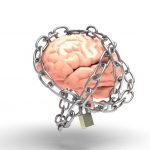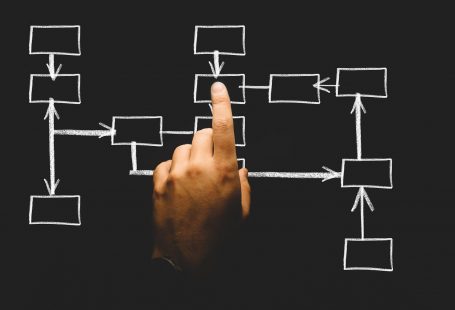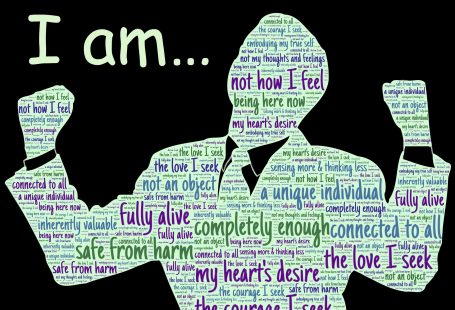Le reti sociali sono luoghi interessanti perché permettono di capire cosa pensano grandi masse di persone semplicemente osservando gli argomenti e i meme che imperversano in un determinato momento.
Comprensibilmente, visto che il contatto fisico è una cosa che piace alla maggioranza delle persone, ultimamente leggo molti post del tipo “appena finisce la quarantena esco di casa e abbraccio tutti!”.
Personalmente ho qualche problema col contatto fisico non richiesto, nel senso che se qualcuno si aspetta un abbraccio come saluto io posso anche entrare in panico, perché è una cosa che non sopporto. Soffro profondamente quando devo parlare con persone che toccano l’interlocutore mentre discutono, insomma, a meno che non sia io a richiederlo perché ne sento il bisogno, il contatto fisico mi provoca parecchia ansia.
Agli abbracci, in particolare, ho dedicato un intero capitolo di Eccentrico, e visto che non riesco a trovare un modo migliore di spiegare quello che significhino per me, ho pensato di riportarlo qui.
ABBRACCI
(tratto da Eccentrico, autismo e Asperger in un saggio autobiografico, ed. effequ)
Il giorno in cui ho capito questa cosa degli abbracci lo ricordo alla perfezione. Avevo sedici anni ed ero alla stazione. Giannantonio era in quel momento il mio migliore amico, anche se probabilmente si sentiva più come un cane guida per ciechi, quando stava con me. Mi spiegava le cose, e io lo stavo a sentire come fosse stato una specie di Gesù redivivo sceso in terra. Una volta, ad esempio, ricordo che eravamo nella sua casa al mare e mi mise davanti una scatola di corn flakes.
«Che c’è scritto qui.» mi disse, con la sua solita aria velatamente intimidatoria.
Credo di avere atteso un’eternità, prima di rispondere. Le sue domande mi innervosivano sempre, non sapevo mai cosa rispondere, temevo ogni volta di poter dire una sciocchezza.
«Dai, mica possiamo stare qui tutto il giorno. Che c’è scritto QUI?» domandò, stavolta indicando una scritta obliqua che usciva dal becco del gallo disegnato sulla scatola.
«Carichi di carica.» sussurrai.
«No!» rispose secco Giannantonio.
«Carichi di carica… C’è scritto solo carichi di carica.»
«Va bene, quelle sono le parole. Ma come vanno lette? Con quella vocina monocorde?» domandò.
Ricordo il panico. A quel punto avevo capito più o meno cosa volesse dire, ma ero completamente bloccato. Dovevo leggere quella scritta come se fossi stato un attore, dovevo dare a quello slogan un’enfasi, certo. Carichi, carica, suggerivano qualcosa di brillante, di energetico. Ma ero paralizzato, congelato.
Lasciai trascorrere secoli e un migliaio di tentativi sempre più frustranti, prima di esplodere in un urlo, imitando la voce di un gallo (quella che immaginavo dovesse essere la voce di un gallo che parla, almeno).
«CARRRICHI DI CARRRICAAAA!!!!» urlai.
«Bravo, finalmente. Vedi? Spesso le parole suggeriscono il tono con cui vogliono essere pronunciate.» fu la lezione di quella mattina. Una lezione che non ho più dimenticato, che ormai è diventata quasi un automatismo.
Insieme a lui studiai la retorica, lo facevamo durante le prove, lui al flauto traversiere e io al clavicembalo. Prendevamo le arie d’opera che dovevamo eseguire col cantante e le declamavamo, mi insegnava i gesti che accompagnavano le parole, l’enfasi della voce e l’espressione del volto. Credo che se oggi sono in grado di comunicare in modo normale, lo devo a quella scatola di cereali e agli anni di prove col gruppo di musica barocca. Lo devo a Giannantonio.
Il pomeriggio in cui ho capito questa cosa degli abbracci, dicevo, ero alla stazione. Il treno era in ritardo, come sempre, e la cosa cominciava a mettermi in ansia. Onnipresente, l’ansia, saltava fuori così all’improvviso, bastava che qualcosa non seguisse il corso stabilito.
Andavo avanti e indietro sulla banchina e rivedevo nella mia testa il film di quando sarebbe arrivato. Immaginai che sarebbe sceso dal treno, gli avrei preso la borsa e saremmo andati verso la fermata dell’autobus. Ero nervoso perché da Giannantonio non sapevo mai cosa aspettarmi, cosa dirgli. Non ero mai sicuro di dire la cosa giusta, e soprattutto era sempre come vincere alla lotteria riuscire a indovinare quale fosse, la cosa giusta.
Finalmente arrivò il treno. Decisi di mettermi ad aspettare all’inizio del marciapiede, per evitare di doverlo rincorrere se fosse sceso più avanti rispetto a me.
Ogni volta che vedevo qualcuno che sembrava assomigliargli, il cuore faceva un tonfo nel petto e prendeva a martellare fastidiosamente. La gente scendeva, mi passava accanto come se fossi stato invisibile e scompariva alle mie spalle, ma di Giannantonio non c’era traccia.
Fu uno degli ultimi a scendere, con calma. Pantaloni corti, beige, calzini bianchi e T-shirt bianca. Sempre.
Mi si avvicinò e mi abbracciò.
Io rimasi pietrificato come al solito, le mani lungo i fianchi mentre lui mi stringeva in quell’abbraccio.
«Non sei contento di vedermi?» domandò, separandosi da me per osservarmi.
«Certo, perché?»
«Ma tu, gli amici non li abbracci mai, quando li vedi?»
Ecco, quel pomeriggio imparai che le persone si abbracciano, quando si vogliono bene. Gli amici, i parenti, si abbracciano quando non si vedono da tanto tempo, o semplicemente per dimostrarsi affetto.
Fu uno schiaffo in pieno volto. Una cosa che avevo visto fare migliaia di volte intorno a me e che altrettanto spesso avevo subìto, quella degli abbracci, eppure non mi ero mai domandato perché gli altri lo facessero tanto spesso. Sembrerà assurdo, ma è così. Soprattutto, a me essere abbracciato dà parecchio fastidio ancora oggi. L’abbraccio ha per me più una funzione meccanica, fisica, che affettiva. Mi piace essere abbracciato forte solo da persone con cui ho una relazione estremamente stretta, e in quell’abbraccio stretto, strettissimo, riesco a lasciarmi andare per un attimo, a sentire il contatto dell’altro su di me come una definizione dei miei propri confini, del mio corpo. Ho necessità di essere abbracciato con forza nei momenti di sovraccarico emotivo e sensoriale, e molte volte questo mio bisogno di essere calmato, contenuto, è stato frainteso. Per questo non riesco a comprendere l’abbraccio come saluto, quello che arriva da una persona poco conosciuta. Perché per me è un momento di abbandono; durante un abbraccio mollo la presa e lascio che sia l’altro a vigilare, a definire lo spazio intorno a me.
Anche adesso che so come funziona, che le persone quando si salutano si abbracciano e quando incontro qualcuno cerco di prepararmi a quel contatto, rimane tuttavia un momento per me imbarazzante e fastidioso.
Se vi piace quello che scrivo, seguitemi anche QUI su Facebook!