Il criterio A-1 per l’autismo nel DSM-5 dice:
A. Deficit persistenti nella comunicazione sociale e nella interazione sociale in differenti contesti, che non siano una semplice conseguenza di un ritardo generale dello sviluppo.
I deficit si manifestano attraverso tutti i seguenti criteri:
1. Deficit nella reciprocità socio-emozionale: varia da approcci sociali atipici e fallimenti nella normale conversazione bidirezionale, a una riduzione della condivisione di interessi, emozioni e affetti, fino alla totale mancanza di iniziativa nell’interazione sociale reciproca.
—————————————–
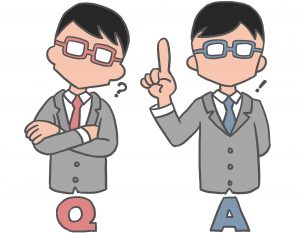 Seduto al suo banco rivestito di formica verde, mentre disegnava un’automobile, ascoltava attentamente cosa la sua maestra stesse dicendo a quella rompiscatole della classe accanto.
Seduto al suo banco rivestito di formica verde, mentre disegnava un’automobile, ascoltava attentamente cosa la sua maestra stesse dicendo a quella rompiscatole della classe accanto.
La signora Ruggiero non gli piaceva, gridava sempre e aveva dei modi sbrigativi e rozzi. Veniva il martedì a cantare con loro in inglese, e alla prima lezione aveva riso di lui. Non voleva che quella donna insensibile e sguaiata entrasse nella sua classe, tanto meno che si mettesse a parlare con la sua adorata maestra.
L’aveva capito da come lo guardavano, che stavano parlando di lui. Non lo sapevano però, le due maestre, che lui riusciva a sentire ogni cosa anche attraverso la confusione dei compagni che giocavano, che aveva un udito incredibile e ricordava tutti i dettagli di una conversazione.
Le cose belle gli si stampavano nella mente accompagnate da una sensazione di tepore e da un profumo dolce, come la primavera. Avevano un loro colore, un loro odore, le cose belle. Quelle brutte gli rimanevano incise nella carne e bruciavano, sapevano di lacrime e solitudine; quelle brutte, soprattutto, non le dimenticava MAI.
La gente parlava spesso di lui alle sue spalle, lo facevano i genitori, credendo che non sentisse (sciocchi, pensava, eppure lo sanno che riesco a sentire anche quando sussurrano), lo facevano i compagni di scuola quando nella ricreazione formavano i loro gruppetti e lui rimaneva seduto al suo banco a disegnare le automobili. Parlavano di lui la mamma e la pediatra quando lo trascinavano a fare la visita di controllo; sua madre parlava di lui perfino con la commessa del negozio di abbigliamento, quella strega che entrava sempre nel camerino quando si stava cambiando i pantaloni.
Non era paranoico, solo pensava che nessuno avesse il diritto di parlare di lui alle sue spalle: se avevano qualcosa da dirgli, che gliela dicessero in faccia. E invece no, tutti vigliacchi.
Quella volta la maestra, parlando con la sua collega, disse una cosa che gli lasciò una cicatrice profonda e dolorosa. Erano in piedi sotto la porta, dall’altro lato della classe, e gli altri bambini approfittavano di quel momento di pausa per schiamazzare, scambiarsi figurine dei calciatori, raccontarsi cose che a lui parevano insignificanti.
La donna si voltò leggermente verso di lui, sorrise, anzi, rise di quelle risate di scherno che lui aveva imparato a conoscere fin troppo bene, e disse alla sua collega: «Che poi è intelligente, finisce sempre gli esercizi per primo».
La confusione non riusciva a coprire la voce della sua maestra.
«Finisce per primo e allora si alza e viene da me a parlare» disse la donna, alzando gli occhi al cielo. «Mi parla di due cose, sempre e solo quelle: di automobili e di sua sorella».
L’altra maestra mise su un’espressione interrogativa, quasi grottesca.
«Che poi, mi racconta cose che questa sorellina un po’ pestifera farebbe che io nemmeno ci credo, che siano vere. Troppi dettagli, un’infinità di dettagli in ogni storia… a volte mi stanca proprio».
Nell’ascoltare quelle parole, pronunciate dalla sua maestra in modo superficiale pensando che non potesse sentirla, avvertì il coltello affondargli nella schiena. Credeva che le facesse piacere parlare con lui, diceva sempre che era intelligente, e adesso risultava che non era così.
Parlava troppo, questo lo diceva anche sua nonna, e zia Assunta, la vicina di casa che badava a loro quando mamma lavorava, anche zia Assunta diceva che lui parlava troppo. Ma gli altri glielo dicevano direttamente, spesso sorridendo, non fingevano di interessarsi e poi lo pugnalavano alle spalle.
In quell’istante apprese un’altra lezione: non solo era vero che parlava troppo, ma parlava solo di cose che agli altri sembravano non interessare per niente. Ed era noioso perché raccontava troppi dettagli. Non sapeva che fare, era così naturale per lui ricordare ogni minimo dettaglio, la disposizione degli oggetti nella cameretta, il vestitino della sorellina, la il modellino di macchina che lei gli aveva rotto, una Mercedes 300 SL grigio metallizzato con apertura delle portiere ad ala di gabbiano.
Lui raccontava della sorellina perché si sentiva orgoglioso, era il fratello maggiore, giocava con lei, badava a lei e soprattutto la osservava come uno scienziato: le cose che faceva, come apprendeva ogni giorno qualcosa di nuovo, le reazioni che aveva a determinate situazioni. Ma agli altri tutto questo non interessava. Ecco perché i compagni lo escludevano sempre, perché lui parlava di quelle cose e in modo troppo preciso, scientifico, monotono; niente figurine dei calciatori, niente partite di calcio. E anche sulle automobili era un problema, coi compagni maschi, perché lui sapeva tutto, sapeva troppo, e allora lo prendevano in giro, dicevano che era pesante e che si credeva più intelligente di loro.
Eppure la cosa che lo ferì di più fu la mancanza di fiducia. La maestra credeva che lui quelle storie le inventasse perché erano troppo precise, c’erano troppi dettagli. Ma lui non mentiva. Non perché fosse un angelo, per carità, ma proprio gli riusciva malissimo. Ogni volta che per salvarsi il culo aveva provato a mentire l’aveva assalito un senso di colpa tremendo e quasi sempre alla fine aveva confessato. Era contro le regole, mentire, e poi era stupido. La realtà è questa, pensava, se non va bene così com’è noi possiamo provare a cambiarla, ma mentire è come far finta che le cose siano diverse da quello che sono. È stupido, ma agli altri piace.
E così, quella mattina in seconda elementare, lui capì che agli altri non piaci se sei troppo preciso quando parli, che loro parlano di cose poco importanti perché altrimenti si stancano. Non capiva il perché ma era così.
Solo che lui proprio non riusciva a parlare di cose superficiali, del tempo e delle partite di calcio che nemmeno guardava. E allora, poco a poco, imparò a non parlare più. Prima coi compagni, poi con le persone importanti nella sua vita, perché anche loro spesso lo rimproveravano di essere polemico e pedante.
Lui così divenne un adolescente silenzioso e scontroso. Certo, quelle rare occasioni in cui gli si dava spago su qualcosa che lo interessava veramente, allora non lo fermavi più. Ma era anche peggio, perché poi quando arrivava il rimprovero, quando il papà gli diceva: «Basta! Non vedi che stai lo stai stancando con le tue domande! Non essere così pesante!», ritornava quel dolore antico e il ricordo, ancora una volta, che tutto sommato è meglio rimanere in silenzio.




