Negli ultimi mesi ho scritto di quanto le parole siano importanti anche nel contribuire ai cambiamenti culturali, insistendo su una visione dell’autismo che vada oltre quella clinica e cominci a vedere questa condizione anche da un punto di vista puramente culturale.
A rischio di sembrare un disco rotto, credo che sia fondamentale ribadire ancora una volta l’importanza del concetto di differenza, diametralmente opposto a quello di patologia.
 La necessità per gli autistici di periodi anche prolungati di solitudine è una di quelle caratteristiche spesso fraintese dell’autismo che deve farci riflettere su quanto sia importante smettere di guardare a questa condizione come a una serie di deficit.
La necessità per gli autistici di periodi anche prolungati di solitudine è una di quelle caratteristiche spesso fraintese dell’autismo che deve farci riflettere su quanto sia importante smettere di guardare a questa condizione come a una serie di deficit.
Nei manuali diagnostici, utilissimi, anzi indispensabili ai clinici per valutare in base a determinati criteri l’appartenenza di una persona allo spettro autistico, la differente modalità di socializzazione degli autistici viene ovviamente definita un deficit. Da questa definizione appare chiarissimo l’approccio clinico che continua a essere ancorato a una visione neurotipica del comportamento umano, etichettando qualsiasi deviazione dalla consuetudine come anormale o deficitario.
Eppure, parlando con chi questa condizione la vive personalmente, è lampante che questi deficit vengono vissuti come tali soprattutto in conseguenza del giudizio espresso dagli altri su di essi. In parole povere, se nessuno ci venisse a dire che non è normale socializzare in un certo modo, noi probabilmente nemmeno ce ne accorgeremmo.
Ovviamente non è così semplice, perché fin dall’infanzia le differenze vengono sottolineate tanto dai genitori e dagli educatori quanto dagli stessi coetanei, finendo per rinforzare l’idea che ci sia in noi autistici qualcosa di sbagliato. Ma proviamo a ragionare per assurdo e ipotizziamo una società che non stigmatizza il diverso limitandosi a prendere atto delle differenze al puro scopo di ottenere un’interazione ottimale tra gli individui che la compongono. E’ una pura utopia, lo so, ma immaginiamolo possibile solo per un minuto.
Cosa accadrebbe al bambino che, a causa di una serie di differenze nell’interpretazione degli stimoli sensoriali, avesse necessità di periodi di silenzio, di assenza di stimoli e quindi si rifugiasse nella solitudine per poter tornare a sentirsi bene? Probabilmente nulla, perché nessuno gli farebbe notare che è strano, che quel bisogno di solitudine non è normale. Anzi, probabilmente quei momenti a lui così necessari verrebbero rispettati e incoraggiati dagli altri anche con una punta di egoismo, per evitare di dover fronteggiare situazioni che possono essere piuttosto spiacevoli per tutti.
Che la solitudine sia in misura differente per ciascun autistico una necessità, lo dimostra il fatto che, quando si parla con una persona nello spettro, si ha spesso l’impressione di un conflitto interiore: vorrei stare con gli altri ma per farlo devo seguire le loro regole, che per me significano un dispendio enorme di energie, e allora mi stanco e quel desiderio di socializzazione si trasforma in desiderio di solitudine. Per me, e per altre persone con cui ho parlato, funziona più o meno così.
Il punto, tanto per cambiare, è sempre lo stesso. Se la società vede come unica possibilità di interazione quella neurotipica fatta di contatto fisico, luoghi rumorosi, chiacchierate in cui le persone si parlano addosso spesso gridando, musica a palla e spinta all’omologazione, allora per noi quella pur presente spinta al contatto con gli altri diventa difficile da gestire. Socializzare perde quella componente di piacere nel momento in cui lo sforzo per gestire le proprie modalità di funzionamento si fa troppo pesante, arrivando a diventare doloroso. E a quel punto è naturale ritirarsi in solitudine.
Un altro aspetto estremamente importante da considerare è quello degli interessi. Noi autistici abbiamo interessi estremamente intensi dai quali ricaviamo piacere. Nello svolgimento di determinate attività stiamo bene, ci bastiamo e non sentiamo la necessità di condividere il nostro tempo con nessun altro. Questa non è una caratteristica esclusivamente autistica (come tante altre, e l’ho spiegato in questo articolo). Chiunque si trova immerso in un’attività piacevole dimentica facilmente le ansie della giornata, del lavoro o della scuola, e in quel momento sta meravigliosamente a solo.
Come ho spiegato durante un incontro a Verona sabato scorso, gli interessi speciali degli autistici non sono necessariamente speciali per la particolarità dell’argomento o dell’attività, ma per l’intensità con cui l’autistico si dedica a quell’attività o argomento. E questa intensità è difficile da comprendere a meno che non la si provi. Un musicista, un attore, un matematico, uno scrittore possono facilmente arrivare a capire di cosa parlo quando per ore restano chiusi nella loro attività preferita come se fossero su un altro pianeta. A me succede quando suono o scrivo: non percepisco quello che mi accade intorno, il campanello della porta, il telefono, il tempo che scorre. E se qualcuno mi interrompe anche solo per chiedermi come va, provo una sensazione di fastidio e sofferenza enormi.
Quando da ragazzino mi rinchiudevo in camera a studiare al pianoforte e mia madre entrava a chiamarmi per la cena reagivo malissimo. Comprensibile il dispiacere di mia madre, che non immaginava l’intensità di quel momento, ma comprensibile anche la mia reazione infastidita, perché una volta rotta la concentrazione bisogna fare un lavoraccio per riuscire a riprenderla.
Tempo fa, dopo una presentazione di Eccentrico, parlavo con una persona autistica conosciuta un paio di giorni prima. Chi ci avesse visto da fuori non avrebbe mai pensato che entrambi abbiamo una fortissima propensione alla solitudine. E in effetti ne abbiamo parlato anche tra di noi, di quanto in realtà a noi faccia piacere stare con gli altri quando comprendono le nostre differenze e le rispettano. In quel momento, inoltre, ci siamo soffermati a osservare quanto all’interno del nostro stesso gruppo (gli autistici) esistono comportamenti estremamente diversi eppure vengono rispettati, perché alla base c’è la consapevolezza del fatto che se ti comporti in un certo modo, avrai le tue buone ragioni.
Da sabato sono a Ferrara per un giro di promozione del libro, lontano dalla caotica Barcellona, dai gruppi di turisti ubriachi, dai vicini rumorosi e dalle strade trafficate. Come ogni volta che viaggio, all’inizio lo spostamento è estremamente traumatico, però dopo un po’ mi abituo. Sono a casa di mia sorella che durante il giorno lavora, e ho la possibilità di leggere e scrivere nel silenzio più assoluto. Eppure mai come in questi giorni ho apprezzato il piacere di trascorrere qualche momento con le mie cugine e con i loro amici, o con mia zia. E’ stata proprio la consapevolezza improvvisa di quanto a me faccia piacere stare con loro perché posso essere me stesso e di quanto poi, dopo un aperitivo insieme al bar, io abbia la possibilità di tornare a casa e godermi il silenzio, a farmi riflettere sulla solitudine.
La parola deficit richiama immediatamente l’idea di un guasto, anche se quel guasto in realtà è tale solo se messo in relazione al funzionamento di qualcun altro. La maggioranza sceglie cosa è giusto e cosa non lo è in modo piuttosto arbitrario, spesso lasciandosi trascinare dalle mode del momento nei propri giudizi. Lo vediamo nei tanti cambiamenti che le culture subiscono col passare del tempo. Per come la vedo io – e sicuramente posso sbagliarmi – ora più che mai c’è bisogno di osservare invece di giudicare, di porsi domande invece di ostentare certezze.
La neurodiversità è una realtà che è sempre esistita, non è una moda o una novità, così come sono sempre esistite le differenze nell’orientamento sessuale, nel colore della pelle o degli occhi. Il discorso è semplice ma non banale, come la soluzione al problema. Semplice, ma per niente banale.
P. S. vi lascio qui il link a un meraviglioso brano scritto da Henry Prucell intorno al 1685, O Solitude, my sweetest choice. Leggete il testo, ascoltate la musica, meglio in solitudine, godete di questo momento con voi stessi, che non c’è assolutamente niente di male.
O solitude, my sweetest choice, Z. 406
Text by Katherine Philips (1632-1664)
Music by Henry Purcell (1659-1695)
O solitude, my sweetest choice:
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!
O solitude, my sweetest choice.
O heav’ns, what content is mine
To see these trees, which have appear’d
From the nativity of time,
And which all ages have rever’d,
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.
O, how agreeable a sight
These hanging mountains do appear,
Which th‘ unhappy would invite
To finish all their sorrows here,
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.
O, how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo’s lore,
Without the pains to study it.
For thy sake I in love am grown
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too,
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.
O solitude, O how I solitude adore!
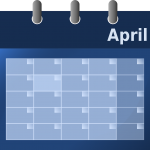




1 comments On O solitude, my sweetest choice
Mio figlio, quando era molto piccolo, aveva inventato un termine bellissimo per comunicarmi il suo bisogno di solitudine: “mamma, mi devo angolizzare” 🙂