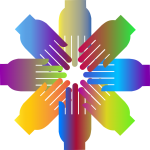Ho trascorso gli ultimi mesi chiudendomi sempre di più nella mia bolla. Dovevo finire di scrivere il nuovo libro e l’unico modo è entrare nella bolla. Mi ha ricordato tanto la mia adolescenza, questo periodo di estrema concentrazione, perché quando sei un ragazzino puoi ancora permetterti di non pensare a quelle cose noiose come il lavoro, la burocrazia, lo scaldabagno che esplode oppure la spesa al supermercato.
Effettivamente da ragazzo l’unica preoccupazione che mi impediva di dedicare tutto il mio tempo ai miei interessi assorbenti era la scuola. Fosse stato per me avrei trascorso la giornata intera a studiare appiccicato al pianoforte o al clavicembalo, o leggendo i miei libri di psicologia. Mangiare sì, ma anche lì era abbastanza una seccatura dover interrompere lo studio o la lettura per andare a sedermi con la famiglia, ascoltare discorsi che non m’interessavano, che ha fatto zia Liliana, ma lo sai che in casa dei vicini sono entrati i ladri e com’è andata a scuola oggi, come vuoi che sia andata, il solito strazio e no, davvero anche questa cosa di dovermi sedere con loro perché si fa così, è sempre stata per me incomprensibile.
La cosa migliorò per un breve periodo finito il liceo – anche quello un calvario, va detto – perché almeno non dovevo perdere metà della giornata in classe. Che poi, diciamocelo, a me studiare piaceva, mi ci prendevano in giro e anche parecchio per l’aria da secchione, ma era quella cosa di dover andare a scuola che non mi è mai andata giù.
A quei tempi se in classe non capivi qualcosa non andavano tanto per il sottile. Se le tue modalità di apprendimento non coincidevano con l’unico metodo possibile che ti veniva imposto eri svogliato, o pigro, o stupido, o semplicemente mediocre. Oppure, come capitava a me, alcune professoresse mi adoravano e altre mi trovavano un caso umano.
L’inglese, la storia, il latino e la biologia ad esempio erano materie che adoravo, e lì prendevo buoni voti nonostante faticassi tremendamente a seguire quel sistema di apprendimento standardizzato, troppo disordinato e dispendioso in termini energetici. Loro partivano sempre dallo studio delle regole. Per me l’unico modo possibile di imparare qualcosa è fare invece quello che viene definito “reverse engineering”, e cioè partire dall’oggetto di studio nella sua interezza e smontarlo a poco a poco, togliere un pezzetto alla volta e domandarmi a cosa serva.
Lo facevo da ragazzino con le radio, gli allarmi (per le centraline degli antifurto avevo una passione davvero insolita), qualsiasi circuito elettrico mi capitasse a tiro. E utilizzavo lo stesso metodo per lo studio delle lingue: non sono mai riuscito a partire dalla grammatica, l’ho sempre vista un’assurdità, una cosa priva di senso. Io le lingue le imparo ascoltando a lungo, come i bambini. Prima la cadenza, poi a poco a poco in quel flusso incomprensibile comincio a trovare elementi che si ripetono e li isolo, e poi li associo a oggetti, a pensieri concreti e comincio a dare un nome al mondo che mi circonda. Ascolto, osservazione, immersione in una cultura. E poi, normalmente, all’improvviso comincio a dire le prime parole in una lingua nuova.
Ecco, per me imparare qualcosa, qualsiasi cosa, è sempre stato così. Ma a scuola no, bisognava fare come ti dicevano, e allora nelle materie in cui era impossibile barare e usare il mio sistema, ero una frana. Poi a quello aggiungiamo che se una cosa non m’interessa non c’è verso di farmici impegnare, e la frittata è fatta.
No, il periodo migliore è stato il primo anno dopo il liceo, quando mi sono illuso di potermi dedicare a suonare e leggere tutto il giorno. Con metodo, per carità, sono sempre stato molto disciplinato. Sveglia alle sette e mezza, inizio al pianoforte alle otto e mezza. Quattro ore di studio con tre pause da dieci minuti, poi due ore per il pranzo e la lettura e altre quattro ore al pianoforte. E poi palestra, lettura, cena. Ogni sera stampavo un foglio in Excel per il giorno dopo con la scansione ora per ora, i brani da studiare, i libri da leggere e gli esercizi da fare in palestra. Poi sono arrivati i primi esami all’università, perché secondo i miei il conservatorio da solo non era abbastanza, e lì mi sono accorto che davvero non avevo scampo, che sarebbe ricominciata la tortura.
Ma quel primo anno è stato il paradiso. La bolla, la mia meravigliosa bolla. Quel luogo magico in cui ci sono solo io e il mio interesse. Io e la musica. Io e la tastiera del computer. Io e un libro. Una sensazione di pace e soddisfazione che è davvero difficile da descrivere, è qualcosa che a tratti ti scalda da dentro. Soddisfazione, senso di compiutezza, controllo sulla mia vita e niente sorprese, niente imprevisti. L’intensità della concentrazione che si riesce a raggiungere nella bolla è impressionante, a volte comincio a scrivere col sole e senza che me ne accorga è già sera.
Anche da ragazzo era così, quello stato di iperfocus meraviglioso in cui il mondo scompare e finalmente posso essere me stesso, e quanto si incazzavano i miei perché non rispondevo. È pronto a tavola. Silenzio. Devi andare a ritirare i pantaloni. Silenzio. Fabrizio, mi serve una mano. Niente, non è che non volessi, ma davvero non li sentivo.
Questi ultimi mesi sono stati un po’ così, come quel primo anno di università quando non avevo responsabilità e potevo dedicarmi alle cose per me importanti. C’era da scrivere il nuovo libro, fare le ricerche, e bisognava trovare la bolla. Ma adesso non sono più quel ragazzino che viveva coi suoi e poteva rinchiudersi in camera tutto il giorno a studiare. Ora c’è il lavoro, la burocrazia, lo scaldabagno che improvvisamente esplode e le persone a cui voglio bene che usano whatsapp e Facebook e insomma, da solo a scrivere proprio non sapevo come fare a rimanerci.
Ma piano piano la bolla si è ricreata, con molta fatica devo dire, all’inizio solo per qualche ora al giorno. È bastato cominciare a rinchiudermi nello studio dopo il lavoro e staccare il telefono. Non controllare l’email. Soprattutto, chiedere a Maurizio di non disturbarmi a meno che non stesse crollando il palazzo e occuparsi lui di tutto il resto, della spesa, del pranzo e della cena e di mantenere i rapporti sociali col mondo. Un monumento, dovrei fargli.
La mia bolla, quella sensazione indescrivibile di serenità e soddisfazione che non ha altro scopo se non quello di esistere. Scrivere perché mi fa stare bene, e basta. Disconnettermi completamente dal mondo di fuori, così pieno di interferenze, e concentrarmi in quello di dentro che è silenzioso, pacifico, e pieno di cose da scoprire.
Quanto avrei desiderato che l’avessero capita quand’ero un ragazzo, questa necessità di poter entrare nella bolla almeno per qualche ora al giorno. Quanto avrei desiderato non dover fingere di studiare per la scuola, o dover uscire con qualcuno solo perché altrimenti finivo dallo psichiatra perché insomma, sempre da solo non ci potevo mica stare. Sarebbe stato bello perché avrei vissuto quei momenti di concentrazione con me stesso senza sentirmi in colpa, o sbagliato, malato, fuori di testa.
Sarebbe stato bello sapere a quell’età il perché, di certe mie caratteristiche. Chiamatelo autismo o come vi pare, il problema non è l’etichetta che decidiamo di appiccicarci sopra. Il problema è l’impossibilità di essere differente, di fare le cose a modo tuo, di avere interessi diversi dagli altri. Di divertirti in modi che la gente reputa noiosi. Di trovare noioso e insopportabile quello che diverte tanto la gente.
Il problema non è l’autismo, no, è l’incapacità del mondo di comprendere che non siamo tuttǝ uguali. Che si può essere diversǝ anche senza essere malatǝ, o difettosǝ, senza dover per forza a te stessǝ per diventare uguale allǝ altrǝ.