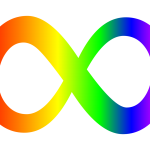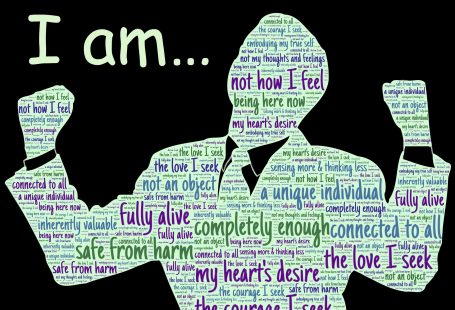Quasi ogni giorno spuntano dal nulla organizzazioni o singole persone che, sicuramente con le migliori intenzioni, dichiarano di aver abbracciato l’idea di neurodiversità e di volerla diffondere attraverso un lavoro di divulgazione e sensibilizzazione, o addirittura tramite proposte di legge e interventi di inclusione in vari ambiti della società.
È una cosa bellissima, si potrebbe pensare, e lo sarebbe se non fosse che in realtà dai contenuti e dalle proposte che producono, molte dimostrano di non aver assolutamente compreso ciò di cui vorrebbero parlare, facendosi inoltre portavoce di un movimento che nasce dalla cultura dei Disability studies e dei Critical autism studies, che a questo punto come minimo andrebbero conosciuti.
Il problema principale è che alcune queste persone e organizzazioni basano la propria conoscenza delle neurodivergenze su informazioni di terza o quarta mano, e spesso decidono di rappresentare un’intera categoria sulla base di una limitata esperienza personale che, sebbene abbia sicuramente un valore emotivo e umano, non è rappresentativa di una condizione estremamente variegata e, soprattutto, ha il valore scientifico di una chiacchierata tra amici, la solidità di un’opinione personale.
E così non passa giorno senza inciampare in obbrobri come “persone con neurodiversità“, “affetto da autismo“, “soffre di autismo” o addirittura, roba da mettersi le mani nei capelli (ad averceli), il capolavoro definitivo: “soffre di neurodiversità“.
Certo, penserete che sono fissato, che vado troppo per il sottile con questa storia dell’importanza delle parole giuste, ma trovo gravissimo che persone e organizzazioni che dicono di voler contribuire a una narrazione “corretta” dell’autismo seguendo il paradigma della neurodiversità, non ne abbiano nemmeno compreso le basi, e in molti casi anche quando gli si fa notare un errore insistano a voler snaturare un concetto rivoluzionario come quello di neurodiversità.
Ma è possibile fare informazione corretta senza sapere ciò di cui si vuole parlare? Come possiamo creare consapevolezza se non ci prendiamo nemmeno la briga di leggere, di parlare con qualche persona autistica, di studiare? Perché è di questo che si tratta, di studiare e di avere il desiderio di confrontarsi con altre realtà e apprendere le une dalle altre. Una cosa è un’opinione espressa a titolo personale, altro sono la divulgazione, l’advocacy, il parlare anche a nome di altre persone.
Bisogna studiare, informarsi ed essere disponibili al confronto perché quando si parla a nome di altri ci si assume una grande responsabilità. Soprattutto se quelle parole usate male, se quelle descrizioni sciatte e falsate di persone che non conosciamo vengono poi utilizzate per scrivere progetti di inclusione nelle scuole o nelle aziende, o addirittura per redigere proposte di legge che avranno ricadute sulla vita di persone che, forse, in quelle descrizioni non si riconoscono. Quindi, ripetiamo insieme: se scrivo o parlo a nome di altre persone, e non solo a titolo personale, sto assumendo una responsabilità che mi richiede studio, verifica delle informazioni e delle fonti, e soprattutto l’ascolto privo di pregiudizi di quelle persone che ho deciso di rappresentare.
Visto che questa storpiatura del concetto di neurodiversità sta diventando preoccupante, ripeto per l’ennesima volta che no, neurodiversità non è sinonimo di autismo, o dislessia o disprassia. Secondo la sociologa e attivista autistica Judy Singer, che ha creato questa definizione (e che ha spiegato chiaramente le sue intenzioni in molti articoli[1] e interviste) la neurodiversità è la variazione naturale delle caratteristiche tra un cervello e l’altro, tra tutti i cervelli e i sistemi nervosi, autistici e non autistici, neurotipici e neurodivergenti. Ogni essere umano appartiene alla infinita categoria della neurodiversità.
La neurodiversità è l’estensione del concetto di biodiversità alle differenze neurologiche tra gli esseri umani. È un concetto importantissimo, quello di neurodiversità, perché ci allontana da una narrazione che vede alcune caratteristiche neurologiche come necessariamente problematiche o intrinsecamente deficitarie, spostando l’attenzione invece sulle differenze. Solo da qui può partire un discorso paritario e reciproco. Differente non vuol dire inferiore o difettoso ma, appunto, differente. Cosa che, tra l’altro, non mette in discussione le difficoltà che alcune di queste differenze possono causare, soprattutto se viste da un’ottica sociale in cui esse potrebbero essere anche il risultato dell’interazione tra la persona e il contesto in cui vive. È fondamentale, il concetto di neurodiversità, perché rende tutte e tutti responsabili delle barriere che inevitabilmente creiamo sul cammino di chi percepiamo è differente da noi.
E quindi no, mettetevelo in testa, non si può dire “persona con neurodiversità“ e non perché lo stabilisco io, ma perché non ha alcun senso, perché sarebbe come dire che è stata scoperta una nuova specie animale “con biodiversità”. Non si può dire di una persona che è “affetta” da una neurodiversità perché sarebbe come dire che un ornitorinco è “affetto da una biodiversità”. La neurodiversità è una condizione che accomuna l’intera umanità.
Se proprio sentiamo la necessità impellente di parlare di autismo e vogliamo usare il paradigma della neurodiversità, allora possiamo dire “neurodivergenza” oppure “neuroatipicità” per indicare quelle specifiche organizzazioni del sistema nervoso che vengono definite clinicamente condizioni del neurodviluppo e che comprendono l’autismo, la sindrome di Tourette, l’ADHD, la dislessia, la disprassia e altre.
Bisogna sempre tenere presenti le implicazioni sociali e identitarie del linguaggio e del suo uso, delle ricadute concrete che le nostre parole e il nostro pensiero hanno su altre persone.
Facciamo attenzione a come parliamo e scriviamo, e anche a cosa chiediamo alle istituzioni e alla società a nome di altre persone. Siamo coscienti del significato delle parole, perché quelle parole descrivono delle vite; provate a immaginare come vi sentireste se vi descrivessero dalla mattina alla sera con rappresentazioni che non vi definiscono affatto, e se quelle descrizioni sbagliate venissero usate anche per azioni concrete su di voi e le persone come voi. Vi sentireste impotenti, sarebbe frustrante, no?
Non basta credere di sapere cosa un’altra persona pensi, cosa provi o cosa desideri, questo è paternalismo. Io stesso, da autistico, quando ho deciso di raccontare questa condizione mi sono messo a studiarla in modo approfondito perché sono consapevole della soggettività della mia esperienza personale. Mi sono confrontato con tante altre persone autistiche e con i loro familiari, con specialisti, con educatori e educatrici, e continuo a farlo quotidianamente perché so che altre persone leggono ciò che scrivo, e sento la responsabilità di dover informare correttamente.
Facciamo attenzione, siamo responsabili, apriamoci all’ascolto ma quello vero, non facciamo inclusione in modo paternalistico perché quella non è inclusione, quella è un’imposizione ad altre persone delle nostre convinzioni e dei nostri pregiudizi su di loro.
NOTE
[1] Un contributo da consultare sull’argomento è questa traduzione italiana di un articolo di Judy Singer: Che cos’è la neurodiversità? https://neuropeculiar.com/2020/03/14/che-cose-la-neurodiversita/
Qui, l’articolo originale in inglese: https://neurodiversity2.blogspot.com/p/what.html?m=1&fbclid=IwAR0WcAs9DopM8HMfKHD8RCNfXbXUTBFopCAz3rVkhxHsnMYXOQDYgLusFDI