Fin da bambino ho sempre nutrito un rispetto reverenziale verso i segni che utilizziamo per esprimere pensieri, stati d’animo, intenzioni.
 Probabilmente è per via della musica: aver studiato a fondo la musica di un periodo in cui c’era una grande attenzione per il valore simbolico dei segni – le note – mi ha reso particolarmente sensibile anche ad altri simboli, come le parole.
Probabilmente è per via della musica: aver studiato a fondo la musica di un periodo in cui c’era una grande attenzione per il valore simbolico dei segni – le note – mi ha reso particolarmente sensibile anche ad altri simboli, come le parole.
Effettivamente trovo il paragone tra la musica e l’espressione verbale piuttosto calzante. Ho sempre avuto grandi problemi a suonare in pubblico senza aver analizzato la musica con attenzione e, al di là della necessità di padroneggiare la tecnica (che mi sembra il minimo: senza mezzi l’espressione è per forza poco raffinata), trovo offensiva l’idea di non provare con ogni mezzo a esprimere nel modo più onesto e limpido possibile il significato emozionale e concettuale di un brano musicale.
Lo stesso accade per la parola: sono convinto che se ne debba fare un uso attento. Ogni vocabolo ha un significato che non sempre corrisponde a ciò che a prima vista potrebbe apparire, ha una storia che contiene in sé le mutazioni del proprio significato attraverso il tempo; le culture cambiano e con esse il senso delle parole muta costantemente nonostante il segno possa spesso rimanere invariato.
Non sopporto chi usa il linguaggio (uno qualsiasi, anche la musica) con superbia, per tirarsela, quelli che per darsi un tono utilizzano costruzioni inutilmente complesse e una retorica pomposa; non mi piace nemmeno chi ha un modo di esprimersi sciatto, chi non cura le parole e non pensa che tutto ciò che dice ha un effetto su chi ascolta o legge.
 Penso che il modo migliore di farsi comprendere sia esprimersi con semplicità, avendo un’attitudine quasi minimalista senza mai scivolare nella semplificazione del pensiero, che è tutt’altra cosa. Forse è per questo che faccio pochi concerti e non sono capace di scrivere tanto quanto vorrei. Quando preparo un’esecuzione musicale o scrivo qualcosa ho sempre un verbo scolpito nella testa: togliere. Togliere il superfluo, eliminare qualsiasi cosa possa mettersi tra l’idea che desidero esprimere o il sentimento che voglio suscitare e l’espressione corretta, fedele di quel sentimento o quel pensiero. Togliere espressioni leziose mirate solo a ottenere un effetto artificioso sull’ascoltatore e sul lettore; eliminare parole inutili, perché la parola è tanto un mezzo fondamentale all’espressione quanto, se utilizzata a sproposito, un intralcio. Ridurre il più possibile costruzioni contorte, perché bisogna sempre pensare che si può essere eleganti e profondi rimanendo semplici.
Penso che il modo migliore di farsi comprendere sia esprimersi con semplicità, avendo un’attitudine quasi minimalista senza mai scivolare nella semplificazione del pensiero, che è tutt’altra cosa. Forse è per questo che faccio pochi concerti e non sono capace di scrivere tanto quanto vorrei. Quando preparo un’esecuzione musicale o scrivo qualcosa ho sempre un verbo scolpito nella testa: togliere. Togliere il superfluo, eliminare qualsiasi cosa possa mettersi tra l’idea che desidero esprimere o il sentimento che voglio suscitare e l’espressione corretta, fedele di quel sentimento o quel pensiero. Togliere espressioni leziose mirate solo a ottenere un effetto artificioso sull’ascoltatore e sul lettore; eliminare parole inutili, perché la parola è tanto un mezzo fondamentale all’espressione quanto, se utilizzata a sproposito, un intralcio. Ridurre il più possibile costruzioni contorte, perché bisogna sempre pensare che si può essere eleganti e profondi rimanendo semplici.
Le parole hanno un peso non solo per l’individuo ma anche per la società. Se è vero che la cultura, al cambiare, può modificare anche radicalmente il significato di una parola, è altrettanto vero che le parole sono in grado di operare modifiche profonde nella cultura stessa.
Susan Gelman e Steven Roberts spiegano che “la lingua può evocare cambiamenti concettuali, non solo fornendo nuove informazioni (…) ma anche abbandonando una vecchia struttura classificatoria (…). I sistemi di classificazione umani subiscono riorganizzazioni nel corso della storia e i modelli di denominazione sono stati spostati per adattarsi a questi cambiamenti” (Gelman & Roberts, 2017).
Costruiamo la realtà assegnando un significato tanto a ciò che ci circonda quanto a quello che percepiamo dentro di noi; raggruppiamo gli oggetti per categorie perché in questo modo riusciamo a organizzare la conoscenza del mondo. Gelman e Roberts dicono ancora che “il linguaggio categorico è normativo anche in un senso più forte e prescrittivo. Cioè, etichette e generici implicano che una caratteristica legata a una categoria non solo è, ma dovrebbe anche essere. Questo è particolarmente vero per il linguaggio generico, che esprime norme che possono persino competere con le osservazioni statistiche: “I ragazzi non piangono” è considerato vero – nonostante sia dimostrabile che è falso – perché esprime una norma.”
 Le parole sono importanti quindi perché contribuiscono a formare la nostra idea di realtà, di come le cose sono e dovrebbero essere. Pensiamo alla parola omosessuale. Fino a non molti anni fa l’omosessualità era definita una malattia poi, frutto di un cambiamento culturale, è diventata una una variante naturale del comportamento umano. Il significato di quella parola è mutato profondamente pur rimanendo inalterato il significante, ossia il segno, la parola scritta. Questo ha rappresentato un cambiamento enorme per tutte quelle persone che prima erano viste come malate e che dovevano quindi essere curate, cambiate, riparate.
Le parole sono importanti quindi perché contribuiscono a formare la nostra idea di realtà, di come le cose sono e dovrebbero essere. Pensiamo alla parola omosessuale. Fino a non molti anni fa l’omosessualità era definita una malattia poi, frutto di un cambiamento culturale, è diventata una una variante naturale del comportamento umano. Il significato di quella parola è mutato profondamente pur rimanendo inalterato il significante, ossia il segno, la parola scritta. Questo ha rappresentato un cambiamento enorme per tutte quelle persone che prima erano viste come malate e che dovevano quindi essere curate, cambiate, riparate.
Ultimamente si parla molto di autismo eppure troppo spesso, anche sui mezzi d’informazione che dovrebbero appunto informare, la parola autismo viene associata alla malattia, e quando qualcuno giustamente precisa che l’autismo non è una malattia, in molti ribattono che queste sono sottigliezze linguistiche. Ho addirittura letto di persone che, spero in buona fede, hanno insinuato che il non voler associare l’autismo alla malattia sia un modo per sentirsi migliori dei malati, come a volersi illudere di essere meglio di qualcos’altro.
Trovo che entrambi gli argomenti siano fuorvianti e pericolosi soprattutto sotto un aspetto: il termine malattia richiama alla mente la parola cura, ossia un intervento mirato a ristabilire il normale funzionamento dell’individuo malato; definire l’autismo un differente neurotipo, invece, non implica la necessità di curare l’autistico. Il punto è proprio questo, ovvero che se qualcuno definisce – anche superficialmente – un autistico malato, sta contribuendo a diffondere e rafforzare una visione dell’autismo come di una condizione disfunzionale da riportare in qualche modo verso la normalità, da curare, appunto.
Per questo è importante utilizzare le parole giuste nel definire le cose, perché il linguaggio che utilizziamo è uno degli elementi che danno forma alla cultura, e la cultura, con le sue definizioni e norme, regola il comportamento della società. Quindi, definendo un autistico “malato”, si fa passare un messaggio che non corrisponde alla realtà, andando contro una visione inclusiva di questa condizione di neurodiversità e appoggiando tacitamente chi nell’autismo vede esclusivamente una collezione di deficit da “riparare”.
Ritorniamo all’importanza delle parole e al peso che esse hanno nella formazione delle opinioni nei confronti di determinate categorie, e consideriamo l’uso indiscriminato che oggi si fa dei termini integrazione e inclusione in riferimento a chiunque sia escluso o a rischio di esclusione.
L’idea di integrazione suppone un adattamento del diverso (diverso per un qualsiasi motivo che vada dalla disabilità alla cultura o etnia di provenienza o all’orientamento sessuale ecc.) alle norme di una società. Questo perché l’integrazione è un processo a senso unico in cui il “diverso”, per forza di cose, deve adattarsi ai modelli che gli vengono proposti come riferimenti per poter funzionare in modo normale in una determinata società.
L’inclusione, al contrario, è un processo in cui l’individuo viene riconosciuto e compreso come parte di un tutto in cui convivono tante parti differenti. Qui la società non impone norme e cambiamenti ma è essa stessa a cambiare in modo da rimuovere quelle barriere fisiche e sociali che, parafrasando Finkelstein and French (1993), rendono le persone con disabilità disabili, impedendogli di partecipare alla società da pari a pari.
Tutte queste potranno apparire sottigliezze agli occhi di chi crede che si debba andare alla sostanza senza troppe “menate”. Ma questo punto di vista non considera che i cambiamenti in una società difficilmente avvengono senza un lento processo di evoluzione dei significati che attribuiamo al mondo che ci circonda, evoluzione alla quale possiamo contribuire facendo molta attenzione alle parole che usiamo.
E ricordiamo sempre che “il modo in cui descriviamo il mondo può rivelare a un osservatore ogni sorta di pregiudizi su ciò che riteniamo rilevante, interessante o degno di commenti, e tali pregiudizi a loro volta riflettono le nostre opinioni su come il mondo è strutturato.” (Horowitz & Frank, 2016)
Riferimenti:
Gelman, S.A., & Roberts, S.O. (2017). How language shapes the cultural inheritance of categories. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Finkelstein, V., and French, S. (1993), Towards a psychology of disability, in Swain, J., Finkelstein, V., French, S., and Oliver, M. (eds), Disabling Barriers—Enabling Environments, London: Sage.
Horowitz, A., & Frank, M.C. (2016). Children’s Pragmatic Inferences as a Route for Learning About the World. Child development, 87 3, 807-19.

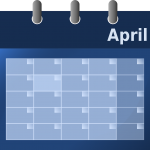
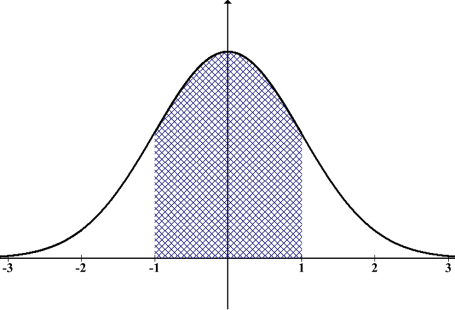


1 comments On Segni, simboli e significati
Pingback: Il servizietto televisivo – Fabrizio Acanfora ()